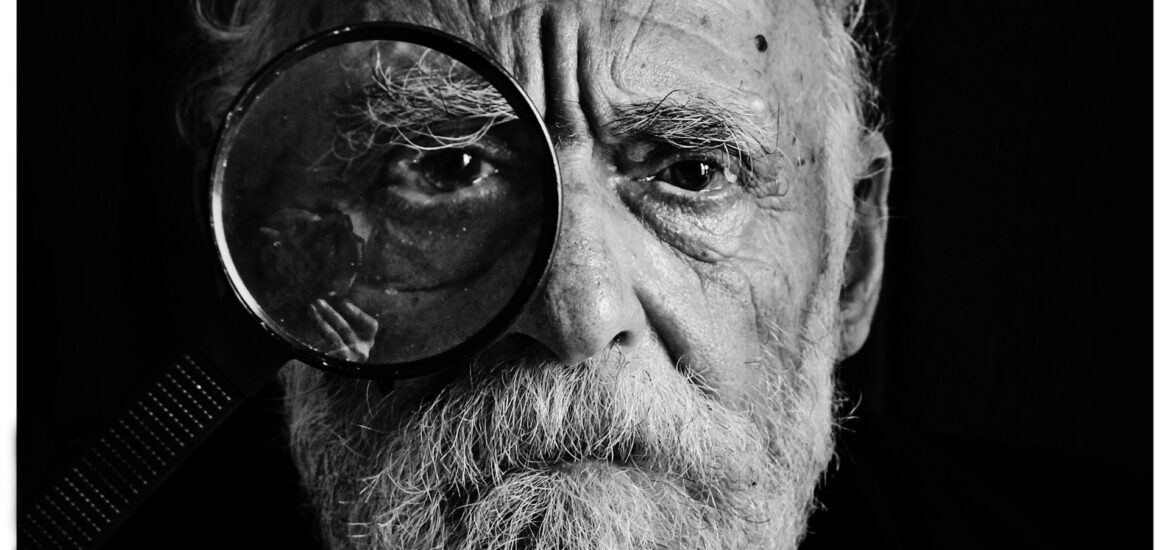Dal cambiamento del clima, alle biotecnologie all’intelligenza artificiale oggi la politica è completamente intrecciata con la scienza. Ma è una novità? Siamo reduci da un paradigma illuminista che vede una netta separazione tra scienza e politica. Benché questo paradigma abbia sempre riconosciuto la buona influenza che la scienza, con i suoi metodi, la sua oggettività, il suo essere orientata al bene comune, può avere sulla politica, le due attività restano fondamentalmente di natura diversa. La scienza concerne la «rappresentazione oggettiva della natura», mentre la politica concerne la «rappresentazione politica della volontà dei cittadini». Entrambe condividono dunque una certa visione della rappresentazione, che potremmo chiamare rappresentazione come corrispondenza. Ossia, la scienza è lo specchio della natura e la politica lo specchio della società. Questa concezione della rappresentazione si concentra sulla sua dimensione cognitiva: rappresentare significa fare affermazioni che rispecchiano la realtà. Ma lascia completamente da parte il laborioso processo di creazione di queste rappresentazioni, l’attività pratica, i valori, gli interessi che entrano in gioco quando si negozia «quale realtà» rappresentare, come rappresentarla e a vantaggio di chi.
Anche in democrazia, il paradigma della rappresentazione come corrispondenza prevale: si crede solitamente che le decisioni di un governo siano democratiche se rappresentano la volontà popolare o l’interesse oggettivo collettivo, anche qui lasciando fuori i processi di mediazione tra la volontà del popolo e la ragione, tra i cittadini e i loro rappresentanti e il complicato intreccio di istituzioni che contribuiscono a questa rappresentazione. Fiumi d’inchiostro sono stati scritti su entrambe le forme di rappresentazione, scientifica e politica. Rappresentare, come scrive Hanna Pitkin nel suo importante saggio del 1967, significa etimologicamente ripresentare ossia rendere presente di nuovo. Rendere presente l’assente comporta un processo di trasformazione, riconfigurazione e mediazione per far sì che quello che c’è sia connesso a ciò che non si può vedere.
In politica, una classica interpretazione del concetto di rappresentazione (si veda per esempio Thomas Hobbes) è quella di semplice «autorizzazione»: rappresentare qualcuno significa essere autorizzati ad agire al suo posto, come quando un avvocato ci rappresenta in tribunale. Ma in che senso questo contratto originario di autorizzazione ci «rappresenta»? Come possiamo essere sicuri che chi abbiamo autorizzato ci somigli? E poi, il delegato sarà qualcuno più esperto di noi in materia: come farà allora a portarsi dietro nella sua rappresentazione di noi stessi i nostri valori, il nostro linguaggio, le nostre insicurezze? In un bel film del 2019, Marriage Story, diretto da Noah Baumbach, i due protagonisti sono una coppia americana sull’orlo della separazione. Si sono molto amati, forse si amano ancora, hanno un figlio insieme, ma non riescono più a capirsi e a condividere un futuro comune. Decidono dunque di separarsi e si rivolgono a due brillanti avvocati, i quali si prendono l’onere di rappresentare la loro rottura davanti al giudice. Eppure, questa traslazione della loro vita nel linguaggio legale li aliena da loro stessi: non si riconoscono in quelle «parole d’amore scritte a macchina», come le chiamava il grande Paolo Conte, che non riflettono il loro amore, i loro veri problemi, la loro solidarietà reciproca sempre e comunque, al di là dei sentimenti e delle incomprensioni. I loro rappresentanti in un certo senso non li «rappresentano». Qual è la parte di noi che migra nel nostro rappresentante? Cosa di noi stessi deve rappresentare? Oggi viviamo nella maggior parte del mondo in democrazie rappresentative, eppure la fiducia nei governi non fa che diminuire, proprio perché i cittadini non si sentono «rappresentati» dai delegati.
Gli stessi dubbi attraversano la filosofia della scienza quando si tratta di comprendere in che senso un teorema, una formula, un grafico, rappresenta la realtà fisica sottostante. Alcuni sostengono che ci debba essere un «isomorfismo» tra la realtà sottostante e il modello matematico che la rappresenta, ossia, che esista una funzione che mappa ogni oggetto della realtà in uno e un solo oggetto (una variabile, un parametro) del modello. Ma si sa che, anche se il libro della Natura è scritto in caratteri matematici, come diceva il buon Galileo, non tutto quel che esiste nella realtà verrà mappato nel modello. I fili d’erba su un campo? Le emozioni degli individui che si muovono su quel campo? Il loro genere diverso? Quali sono gli aspetti rilevanti della realtà che entrano a far parte del modello? Quando un fisico modella l’acqua che scorre nei tubi, la rappresenta come un fluido continuo e non come una sostanza composta da miriadi di molecole. Questo perché le proprietà rilevanti di un modello idrodinamico hanno a che fare con il suo movimento, non con la composizione del fluido. C’è chi sostiene, allora, che sia meglio considerare la relazione di rappresentazione adeguata della realtà come una relazione che permette di fare più inferenze utili sulla realtà in questione. Questi approcci pragmatisti, oggi predominanti, assumono una certa arbitrarietà dei modelli, che sono validi più per le conseguenze che hanno sulle nostre inferenze sulla realtà che per la loro esaustività. In fondo, come dice bene la filosofa Nancy Cartwright, a volte le leggi della fisica non rappresentano la realtà così com’è, anzi: la distorcono, ed è proprio grazie a queste distorsioni che funzionano.