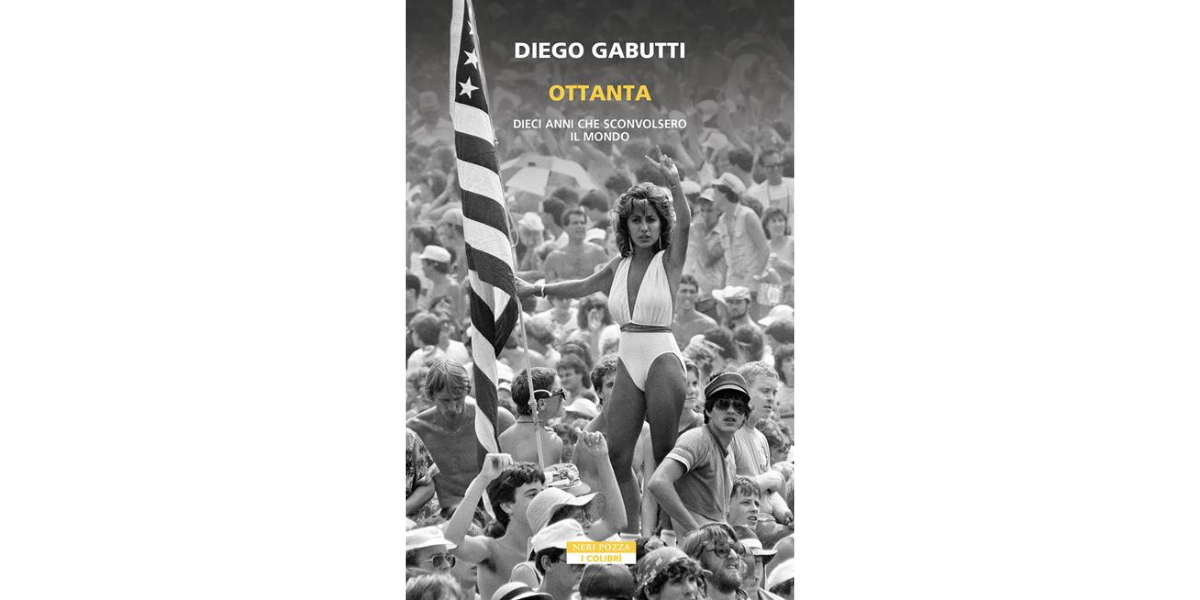La denuncia presentata dai famigliari di Andrea Purgatori alla magistratura, per presunti errori diagnostici e terapeutici commessi rispetto alla malattia fulminante che ha ucciso il noto giornalista, è il coacervo di alcune tendenze rilevanti nella società dei nostri giorni. La prima è il colpevolismo che affligge la sanità e del quale si ha chiara contezza, visto che vengono promosse senza troppo pudore le autocandidature di avvocati che si offrono di tutelare i parenti di pazienti morti in ambito ospedaliero, inducendoli a intentare causa con la premessa che il compenso del legale sarà corrisposto soltanto in caso di vittoria in sede civile: una percentuale sull’indennizzo sancito, cioè. Come a dire: dunque, perché non provarci?
In questo andazzo ritroviamo a sua volta l’incrocio di due atteggiamenti culturali. Il primo è il rifiuto della morte. Non ci arrendiamo più all’idea che ci si ammali e che le malattie possano essere invincibili, letali, ineluttabili. Pensiamo alla retorica che circonda in particolare il cancro, spesso e superficialmente presentato come una patologia alla quale si possa sempre scampare, purché prevenuta, identificata precocemente e trattata con le cure adeguate che la ricerca medica e scientifica ci metterebbero ormai a disposizione. Le cose in realtà stanno molto diversamente e sono molto meno rosee, purtroppo. Il colpevolismo sanitario, se così vogliamo chiamarlo, rientra però in quello generale, nell’idea che quando accade qualcosa di negativo ci sia sempre un responsabile e che questo possa, anzi debba, essere identificato e punito. Tema del quale abbiamo già parlato nei giorni scorsi.
Nel caso specifico di Purgatori, però, entra in campo probabilmente un altro tema. Quello per cui, quando si ammala ed eventualmente muore un personaggio pubblico, queste vicende così naturali e comuni, ineludibili nell’esperienza di qualunque essere umano, diventano un fatto di interesse pubblico. Si tratta di una consuetudine inveterata che nei secoli scorsi ha prodotto anche delle convinzioni metafisiche, come quella che legava la salute dei re a quella dei regni loro affidati, e che ora si è in qualche modo “democratizzata”. Pertanto il personaggio pubblico, o in questo caso anche i suoi famigliari, nel momento in cui contrae una patologia ritiene sia suo dovere, quasi più che il suo diritto, darne notizia al mondo.
Il caso di Michela Murgia è il più eclatante tra gli ultimi, ma anche il trionfo di Ada d’Adamo con il suo libro Come d’aria, che ha vinto il premio Strega dopo la scomparsa della sua autrice (che peraltro, nel romanzo, racconta la sua vicenda di mamma di una figlia con una grave e invalidante patologia congenita), è un’altra dimostrazione indicativa. Per Purgatori in realtà era stato fino alla scomparsa mantenuto un forte riserbo sul suo stato di salute, tanto che la notizia della morte ha stupito e ancor più sgomentato molte persone, ma adesso la scelta della famiglia di presentare una denuncia riporta la vicenda nell’alveo del generale coming out dal quale sembriamo ormai tutti essere coinvolti.