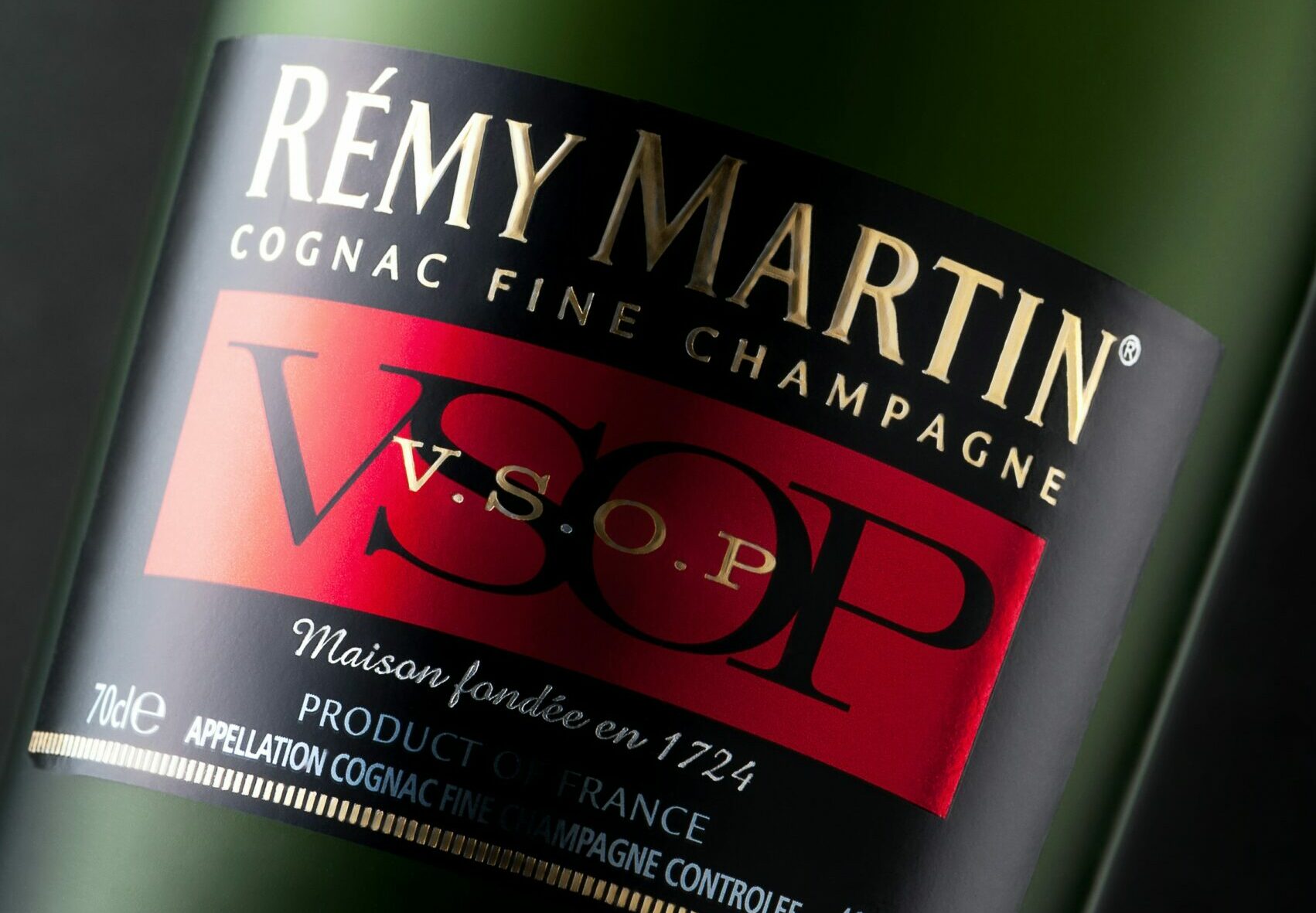Lo scorso marzo deda (nonno) Mirko avrebbe compiuto 126 anni. Era nato in un villaggio della Serbia centrale a pochi chilometri da Kragujevac. Fuori dal villaggio ci era stato poche volte, per esempio nella capitale, ma solo per il disbrigo di pratiche burocratiche, oppure per incontrare suo figlio quando era un militare coscritto del regio esercito jugoslavo, spedito in un villaggio vicino alle Karavanke. Come dire, in un posto completamente diverso, tra quelle Alpi che stavano alle sue colline quasi come una foresta scandinava di conifere sta a un bosco di querce mediterranee.
Era un bell’uomo, deda Mirko. Alto, asciutto, capelli lisci neri portati all’indietro e abbondantemente brillantinati, occhi blu. Si dice che ci fossero tante donne affascinate da lui, le malelingue del villaggio sostenevano che fosse soprattutto per via della sua divisa. Deda Mirko in effetti una divisa la indossava, completata con un cappello d’ordinanza: era autista di autobus in servizio permanente effettivo.
Ma deda Mirko era uomo di sobri costumi: niente avventure femminili, poca frequentazione delle kafana, quei locali tipici dei Balcani e di tutto il territorio ex-ottomano, tradizionalmente frequentati da soli maschi, dove si servono caffé, tè e bevande alcoliche. Era allergico ai giochi di carte. Alla fine dei conti era quasi un vegetariano: si nutriva di insalate di pomodori e cetrioli, di un po’ di kajmak, un derivato del latte, e di molto pane. Nei giorni di festa, quando tutta la famiglia divorava di tutto, deda Mirko si lasciava andare a quello che riteneva uno strafare: una pljeskavica, polpettina di carne, innaffiata da un paio di bicchieri di rakì. Nessuno lo vide mai addentare polli, agnelli o maialini allo spiedo, né tanto meno prosciutti o insaccati
Suo figlio, quello poi spedito a fare il militare sotto le Karavanke, era tutto il contrario di suo padre: piuttosto bassino, capelli biondi sempre in disordine, occhi neri, qualche chilo di troppo. Tutto sua madre, si diceva, con quel tanto di sottile maldicenza comune nei villaggi, fondata sul principio della certezza della maternità e la non provabile paternità. Al contrario del padre, adorava passare le serate alla kafana a giocare con gli amici e a bere. Si chiamava Miloš e il suo punto di debolezza era la passione per le donne, cosa che gli provocò non pochi problemi, incluse fughe rocambolesche per i tetti inseguito da mariti che avevano colto la propria moglie in flagrante adulterio. Come un don Giovanni, non andava per il sottile: tutte gli andavano bene, purché portassero la gonnella.
I nazisti invasero il Regno di Jugoslavia nell’aprile del 1941. Miloš fu richiamato e spedito al confine Nord. Ma l’esercito regolare non resse. A Miloš si pose allora il dilemma: andare con i četnici, con i partigiani comunisti oppure nascondersi.
Deda Mirko, come tante persone delle sue parti, era un monarchico convinto. A capo del suo letto aveva un ritratto del giovane re Pietro II, le icone stavano da altre parti della sua casa. In effetti, oltre che monarchico era anche molto religioso, e specialmente a quel tempo i due sentimenti coincidevano. Sua moglie Olga aveva la fama di grande cuoca: non c’era infatti famiglia nel villaggio che non volesse affidarle la preparazione di pranzi per una festa di nozze, una svadba, e tanto contribuiva non poco alle entrate della famiglia di deda Mirko. Una famiglia che aveva raggiunto un certo benessere (definirla agiatezza sarebbe eccessivo) in confronto al livello di vita dei compaesani.
Per risolvere il dilemma a Miloš sembrò naturale rivolgersi per primo a suo padre. “Che cosa mi consigliate di fare, tata?”, fu la domanda, rivolta usando la seconda plurale, come era d’uso con il genitore maschio, e non la seconda singolare, riservata solo alle comunicazioni con coetanei ben conosciuti o con sconosciuti di età chiaramente inferiore. Deda Mirko ascoltava suo figlio e si ravviava i capelli con la mano destra, lo sguardo rivolto alla credenza del soggiorno, la dnevna soba, e non agli occhi di suo figlio.
Deda Mirko non teneva in grande considerazione i partigiani comunisti, diciamo anzi che li considerava un pericolo più o meno come i tedeschi. “Se ti nascondi in mezzo al fieno, nella nostra piccola stalla o in quella di un vicino prima o poi ti trovano”, replicò deda Mirko, “tanto vale che ti esponi direttamente, e io ti dico che dobbiamo difendere il re; è quello che farei io se avessi dieci anni di meno e se ancora mi volessero”. E così, per obbedienza verso il padre prima che per convinzione, Miloš si registrò nell’esercito monarchico resistente e non raggiunse mai i partigiani.
Intanto i tedeschi occupavano il villaggio, mentre deda Mirko continuava a indossare la sua uniforme di autista e a guidare l’autobus. Alle ristrettezze della guerra si accomodava senza grande sforzo: era abituato a mangiare come una pticica, un uccellino, e per fortuna la rakija non mancava, così come non era una grande impresa trovare pomodori, kajmak e uova, tutto quello che gli serviva per sopravvivere. E poi aveva al suo fianco Olga, che da quelle poche e povere materie prime poteva tirar fuori, se non un pranzo da re, almeno uno da knez, da principe.
La guerra stava finendo, e finì. I liberatori non erano di quelli che deda Miloš preferiva: erano partigiani comunisti (per precisione di cronaca riporto che li definiva “ladri di galline”), ma il giorno in cui si misero tutti a ballare per strada (e a fare ben di più nella kafana, più tardi) c’era anche lui, deda Mirko. Di Miloš non si avevano ancora notizie, e non se ne sarebbero più avute.
I tedeschi erano stati scacciati, i partigiani comunisti avevano vinto, i četnici avevano perso. Soprattutto, il mondo non era più quello che deda Mirko aveva conosciuto, quello di prima della guerra. Cominciava a essere un mondo nuovo, dove non c’era lo spazio di prima per persone come deda Mirko, čika Pera (il padrone della kafana), tetka Marija (la sarta) o tetka Aleksandra (la padrona della macelleria).