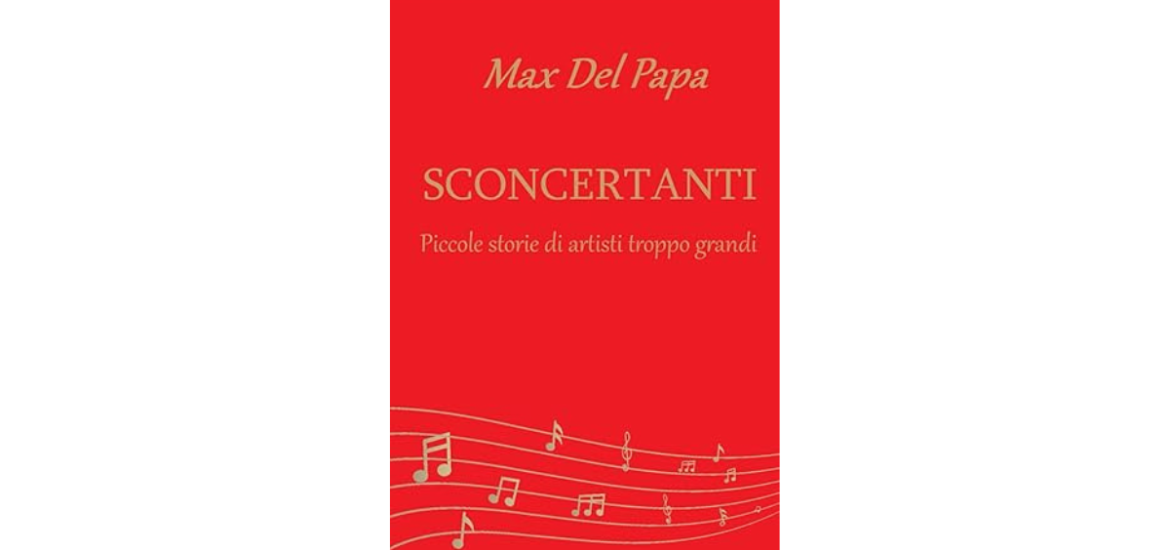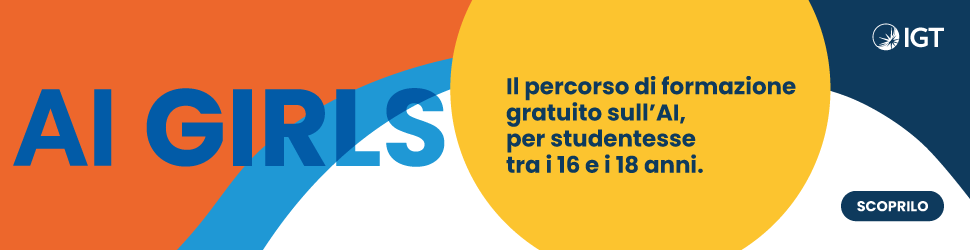Pare ieri che se n’è andato portandosi via Milano. Perché non c’è niente da fare, son quegli uomini lì, nati per essere pianeti e intorno hanno un sistema. Il sistema Jannacci era un cabaret continuo e cangiante, fatto di Cochi e Renato, Dario Fo e Gaber, più avanti Abatantuono e un sacco di quella gente lì. Lui al centro, con le sue canzoni che sembra che ridi e ti ritrovi a piangere di una disperazione milanese, perché c’è la saudade anche a Milano, basta saperla trovare, in quei bagliori di cielo metallico o di sole che sfonda, in quella luce polverosa che raramente è tersa e quando è tersa allora fa piangere di più perché uno dice, ma non potrebbe sempre essere così. E l’Enzo con gli occhiali da nerd che invece prende tutti per il culo, ma mica per cattiveria, è fatto così, gli viene così, se entra uno strano lui e Beppe Viola, altro fuori di testa creativo, si guardano, eccone uno dell’Ufficio Facce. E che altro puoi fare a Milano se non esorcizzare così la saudade? Una vita tutta così da lucido pazzo, o pazzo lucido, fai te, è uguale, e poi muore a Pasqua, una Pasqua anticipata, ma è un dispetto da carogne, da artisti, da disadattati. Lasciar lì il posto vuoto era l’ultimo sberleffo da giullare, da cantastorie messo da parte e così Jannacci si vendicava arrendendosi al male di venerdì santo, lui che in chiesa non ci andava ma dentro aveva “un seme, qualcosa che cresce piano piano”. Sparito nella pioggia insieme con le visioni di anni, di luoghi catturati nei solchi dei dischi e dei giorni. Milanese, nevrastenico come quella “J” del cognome, che ci fa lì addosso a un meneghino, ma poi si scopriva che veniva su dal sud, l’origine era pugliese, come gli altri folli del Derby e dintorni, Celentano, Teocoli, gente che nel dopoguerra aveva ridipinto Milano di demenziale poesia.
Pugliese di stirpe macedone il nonno, i balcanici son sempre venuti di qua italianizzando il nome. Un terrone, chi l’avrebbe detto, pareva tanto milanese. Forse per questo l’Enzo “cresciuto nella prospettiva periferica di Lambrate”, vedi un po’, aveva sempre così dentro la gente del mare, che affogava in mare, ce l’aveva dentro come un seme di dolore, di passione, che cresceva pian piano. Eh sì, noi di Lambrate, che la notte dormivamo col latrare del megafono della stazione che chiamava i treni, siamo gente di nostalgia marina, ce lo vediamo lungo la via Porpora quel mare, lungo la tangenziale che da via Rombon poi ti ci porta, al mare.
Ed è per questo che il pianista “studiato” al Conservatorio, jazzista e improvvisatore, performer, paroliere, compositore e pigliaingiro allampanato, matto in scena, affidabile in camice, non aveva mai smesso quell’umanità stralunata, fosse su un palco o in sala operatoria. Che gli basta un pugno di parole sparpagliate, cucite dal filo spinato ed esile di una fisarmonica ed eccolo lì il blues alla milanese fatto di case di ringhiera e di borgate, di ombrelli e fiori nel fango, di cardinali e disperati, di fabbriche spietate per chi ci lavorava e la finta pietà di chi ti scarica, “Se me lo dicevi prima”, “Ma io sto male adesso”. Dai, va bene anche l’armonica, una storia di parole deliranti e desolate ed eccolo lì quel blues bianco, italiano, milanese, di ringhiera, che fa star male, che mette l’angoscia peggio dei vortici dei filosofi, perché è più facile specchiarcisi, riconoscerla, cascarci dentro a quella malinconia da due soldi con attaccati sui cancelli certi cartelli di cartone, “Attenzione cane morsicoso”. Ma adesso non ci sono più neanche quelli, ci sono le piste ciclabili in Buenos Aires che ci vanno i monopattini elettrici, peccati che sei morto Enzo se no una canzone su questa roba qua non ce la levava nessuno. Con le parole farfugliate, “Io non sono un cantante, c’ho quella vociaccia lì”, surrealisticamente masticate dal vernacolo dei Navigli o di un altro dove di periferia, ma italiane. Parole sincopate che inzeppano versi che riempiono frasi che farciscono discorsi che gonfiano canzoni che non sono canzoni sono frammenti distonici lunatici di storie, pezzi di vita e alla vita – alla vita, non alle sue proiezioni, non alle sue elucubrazioni – va resa tutta la dignità della vita, e la dignità della vita è fatta di sconfitta, di sincerità, di verità nel dolore, in quell’angoscia che chiunque può riconoscere perché è anche la sua.
E così questo pianeta con gli occhiali cantava il blues dell’Ortica e di Lambrate, struggente e crudo, senza speranza, senza lieto fine, e metteva un brivido perché aveva il coraggio della poesia, di guardare in faccia la realtà e cantarla per quella che era. La realtà. Che non è fatta di gesti eroici e di cadute tragiche, ma di matti non capiti, di barboni che muoiono per una sigaretta, di derelitti che si vendono la radio, di donne che non capiscono e di vita che non si capisce. Solo vita, piena di vuoto, piena di poesia da buttare, piena di ingiustizia senza redenzione come può esserla quella di chi vuole andare allo zoo e non ce lo lasciano andare.
Jannacci e il jazz, i concerti con Stan Getz, Gerry Mulligan, Chet Baker e Franco Cerri, l’apprendistato con Bud Powell che gli insegna la tecnica della mano sinistra al piano, quella era una per davvero, distopica distonica fin che vuoi ma tutti ci passavano anche i malavitosi e i delinquenti quelli veri e lasciavano una scia, ribollente di occasioni, di rielaborazioni, il rock and roll alla milanese con Gaber, i due Corsari di fine anni ’50, e ancora Ricky Gianco e in fila tutti gli altri e sono tanti in quella Milano là ad agitarsi sulle tavole dei teatri e i cabaret, e Jannacci che li filtra, li imbarca, li cresce, li lancia, li ispira, li tortura la notte, dopo lo spettacolo, a studiare sui libri di Medicina, a catturare nuove melodie, intercettare nuove parole, nuovi fili d’armonica, nessuno dome quando l’Enzo è sveglio, “Ho visto un re” e sprazzi di disperazione tirata via, beffarda, ma se uno cerca un’eredità da Jannacci gli viene in mente l’allegra rasoiata di “L’importante è esagerare”. In Italia esagerano tutti, sempre, comunque, quella canzone potrebbe, dovrebbe essere il nostro vero inno nazionale. Anche Jannacci esagerava. In follia: una volta sull’aeroplano tirò matta una hostess, che lui voleva un caffè fatto così e così e quella poverina andava e veniva e non ne usciva viva. Poi lui le fece una carezza, era tutto uno scherzo. Sai quelle persone lì che hanno paura del vuoto, che pensano anche troppo e allora debbono inventarsi sempre qualche mattana da raccontare se no succede il patatrac. Diceva il chirurgo dal cuore umano: “Ho visto guarire più gente per la compagnia di un gatto che per le medicine”.
Nell’Italia degli esagerati e dei folli, capace di fare un motivetto terribile che per quasi tutto il tempo fa piripiripirì pirippippi piripiripirì… E ci ha pure successo, che i bambini ridono ma i grandi, se capiscono, gli viene da piangere. Perché poi non è solo quello che diceva, è che sapeva buttarci addosso una musica triste, ma così triste. E se n’è andato via un venerdì di passione, come in una della sue assurde storie in musica, portandosi dietro graffiti di una Milano che i giovani non sospettano e che sopravvive, quando sopravvive, nel rimpianto, la cartolina di un Duomo seppiato, treni addormentati su binari morti, ritratti deragliati di quella Milano agra, alla Bianciardi ma anche alla Jannacci, una domenica pomeriggio Viola che il buio già l’inghiotte, finisce una partita squallida, la gente si vomita fuori da San Siro, s’inscatola nei tram, si prende a gomitate, si disperde nei rivoli delle vie, entra nei bar di luce sporca a farsi l’ultimo bicchiere della domenica pensando che domani è un altro infame lunedì di un’altra settimana di ringhiera e Milan sarà anche un gran Milan ma a quest’ora in bianco e nero, con le strade che si vuotano e la nebbia che le lucida, non pare proprio. Ma adesso vogliono buttar via anche San Siro coi suoi fantasmi, San Siro, ci pensi, che tu avevi lì il tuo posto personale, riservato, pentolone d’umanità che ti serviva poi a immaginare altri blues ed è come se vi uccidessero una seconda volta a tutti voi, ma come si fa a cancellare cent’anni d’emozione Enzo dimmelo tu se è possibile un crimine così.
Quella prospettiva periferica di Lambrate noi la conosciamo bene: non tra i Quaranta e i Cinquanta, quando cresce e si forma, lui è del ‘35, ma almeno tra i ‘60 e i ‘70 sì, fu roba nostra, metabolizzata, custodita; almeno se credete a uno che come primo disco, primo 45 giri della sua vita ebbe in regalo Vengo anch’io, ma sull’altro lato c’era il Giovanni Telegrafista e “pirippiripiripirippippì” che metteva addosso una tristezza della Madonna, una roba proprio che ti entrava nel sangue per non andarsene più. E se questa non è santa cattiveria, se questo scavare nella disperazione sottile ma senza scampo non è essere spietati, allora trovatemelo voi un altro più pericoloso.
È che Jannacci ti fotteva con la follia, dinoccolato storto svagato, ti diceva “io sono qui per divertirti” ma ti faceva venir voglia di buttarti sotto a un tram con quei tanghi, quelle filastrocche e lisciate blues di ringhiera, di prospettiva periferica. Ambiguo, come tutti gli unici geni: “Se cominciate a capirmi, ditemelo che sto uscendo dal personaggio”. E ammiccava furbo. Un pazzo, ma calcolava tutto, le isterie e le tenerezze, le gabbie di nebbia della metropoli e gli spasmi di libertà che tanto era impossibile da raggiungere. Folle lucido o calcolatore benevolo? Ovviamente entrambi, chi l’ha detto che non si possa essere disadattati sapendolo? Jannacci dà l’idea di un direttore del circo, uno che li dirige tutti, anche il Fo, anche il Gaber, ma resta al di fuori, ogni tanto fa il numero ma preferisce osservarli, indirizzarli, come con Cochi e Renato. Dal Derby agli altri locali fumosi e malfamati della Milano d’oro, dove potevi trovarti in platea Turatello con la pistola madreperlata e pensavi: se questo adesso non si diverte, se lo annoio, capace che mi fa saltare la testa.
A questo punto io dovrei parlarvi di cosa fosse quella Milano con dentro Jannacci e viceversa, e non so, francamente, se ci riesco. Direi una metropoli felicemente crudele, dove c’era posto per tutti, la seconda invasione, dei “terroni” dopo quella contadina di inizio secolo, poteva assorbirla senza traumi e anzi dava a tutte quelle masse foreste un ordine sociale, che la sociologia avrebbe chiamato, in modo sprezzante, “inurbazione”, ma son di quelle formule che usano gli intellettuali per rifiutare realtà che a loro repellono; bastava dire un gran casino, che ribolliva ogni giorno di più, le periferie facevano schifo, ma, vedi caso, nessuno tornava mai al borgo, salvo i quindici venti giorni d’estate che non vedeva l’ora passassero. Aveva scoperto, tutta quella brava gente senza indirizzo e senza futuro, l’illusione almeno di un futuro, aveva capito che correndo correndo, anche senza sapere per dove, per cosa, ci si poteva costruire su il sogno, l’ascesa dal sottoproletariato agreste o marinato alla piccola borghesia di Lambrate dove potevi incontrare l’operaio, il chirurgo, l’assessore omosessuale. Anche Enzo era chirurgo, non si è mai capito se come primo o secondo lavoro. Forse i geni unici possono fare più cose e tutte con la medesima serietà imbizzarrita, apparentemente caotica ma improntata a rigoroso scrupolo. Studia con Barnard, il divo chirurgo, il primo a fare un trapianto di cuore, e suona con Chet Baker: chi è questo Jannacci che va allo stadio, a tifare il Milan, con una scuffia alla Greta Thunberg, personaggio che lo avrebbe divertito, e pretende di avere il suo seggiolino semplicemente firmandolo? È uno che suona, organizza, crea, produce, cura, si scatena nella Milano degli ottimisti e degli scalmanati, dei primi travoni che suscitano scandalo e attrazione e delle disgraziate salite dal profondo sud e messe a battere dal marito pappone, sconto per gli amici e gli zanza, i piccoli delinquenti che posson sempre tornare utili nel termitaio feroce; qualcuna si adegua, qualcuna non ce la fa, scappa, torna al paese oppure si fa ammazzare dal marito magnaccia oppure lo ammazza lei. Per dire della Metropolis babelica in cui, e dove sennò?, a un certo punto comincia il terrorismo brigatista, i primi roghi, le fabbriche nel mirino, le macchine arse, l’incendio della prateria, nella prospettiva periferica di Lambrate salterà fuori uno dei covi più importanti, nel ‘78, in via Monte Nevoso, dove in nove custodiscono il memoriale Moro, ci sono i pezzi da novanta come Azzolini, come la Mantovani, va e viene anche il capo Moretti che però lo lasciano stare, Dalla Chiesa non lo prende e un po’ perché non vuole, gli serve ancora libero per capirne di più, e un po’ perché non può, deve aspettare altri 2 anni quando, con la scusa della soffiata di un tossico, lo prendono a duecento metri dalla Stazione Centrale.
A Lambrate si agita anche Vallanzasca, il bandito della Comasina che poi si è trasferito in altre prospettive periferiche e finirà per giocare a pallone con la testa di Turatello; o era il vice, l’Ugo Bossi? Va beh, comunque la madre ha una merceria in via Porpora e lui sa molto anche dei terroristi nel quartiere, che peraltro ribolle anche di fascisti e di elementi dei Servizi: due giorni dopo via Fani, il duplice omicidio di Fausto e Iaio, i diciottenni del Leoncavallo, per mano nera, mitragliette sotto gli impermeabili a fibra di vetro, forse è stato Carminati quello dei Nar, er ciecato, ma non si arriverà mai a niente. Fausto abita anche lui in via Monte Nevoso, frontale al covo, se si affaccia dalla sua camera lo vede come lo vedo io, che ho 14 anni e non ci penso, ma mia madre, che soffre d’insonnia e la notte si alza a bere, scorge sempre quella tapparella rotta, di sbieco, da cui filtra la luce e, da donna suggestionabile ma istintiva, ci ripete: e io vi dico che lì dentro ci son dei brigatisti.
Dieci anni prima, altri banditi. La banda Cavallero e lì andate a leggervi, subito, il libro di Giorgio Bocca che parte dai balordi torinesi, della barriera di Milano e arriva all’affresco della grande puttana città. Dove, nel ‘67, nel pieno di una rapina in fuga, a mio padre che nel fantasmagorico bordello meneghino corre, come tutti, appresso alle rate, ai Natali consumistici, agli impegni che non portano a niente, capita una raffica di mitra che lo spettina: sono loro, quelli di Cavallero, inseguiti dalla polizia, “Milano spara”. Lui torna a casa sotto choc e fa a mia madre: per venti centimetri non sei vedova. E l’Idroscalo, “il mare dei poveri di Milano”, con i puttanoni materni ma meglio non allargarsi, il mare di roulotte che non si muovono, inchiodate lì a vita, e il Ragno d’Oro, alle Varesine, dove si fa l’usura e il racket delle troie ed entri solo se i picciotti mafiosi fermi davanti in macchina ti fanno passare. Tutta la merda e tutta la gioia, frenesia e squallore, corri, corri e la sera rintanato in casa con Dorelli e Mike Bongiorno, a sognare le coscette corte della Carrà. E la domenica il Milan, il derby con L’inter, Rivera e Sandrino, da qualche parte seduto c’è anche l’Enzo con qualcuno della sua cerchia di impossibili. E quando tutto è finito, quando si risale sui tram per sparpagliarsi verso le proprie tane, non c’è posto più disperato di San Siro, di Lambrate, di Metropolis dove il cielo manzoniano, così bello quando è bello, nessuno lo vede mai. Perché è un posto che sembra inospitale, però poi ti abbraccia, però resta distante, però ci sei dentro, non sei mai estraneo, però puoi anche sentirtici la persona più sola del mondo. Milano non è Roma, non ha quel torpore maestoso, le sue mura sono spagnole, non latine che puzzano ancora di sangue, e non è Torino aspra e ventata dalle Alpi, dominata dalla Fiat e da Agnelli, e non è Napoli dove tutto è possibile perché niente è reale; Milano asburgica è la locomotiva di un Paese ferocemente vitale che non sa dove corre ma non rallenta mai e offre occasioni di lacrime nere e di risa amare o crudeli o fuori di testa. Ha, dicono, “il cuore in mano” ma a volte, spesso, è un cuore scuro e devi arrangiarti a farlo funzionare. E la domenica, quando tutto si ferma e funzionano i cinema e i ristoranti e il centro si riempie, gliela vedi addosso a tutti la maschera della noia, Dio fa’ che passi subito anche quest’altro giorno inutile così domattina ricominciano a rotolarci, a correre senza sapere perché ma pur di farlo.
Adesso ditemi voi due cose: se uno come Jannacci poteva venir fuori altrove, e se poteva mai non venir fuori, lì dove ha vissuto, ha immaginato, ha pianto. Ha respirato polvere d’amianto e di prato, di fretta meridiana e di indolenza notturna. Bislacco umano feroce: “Ho visto più gente guarire per la compagnia di un gatto che per le medicine”, ma canzoni come Vincenzina e la fabbrica ti fanno secco. Quell’altro così a mal partito che si vende anche la radio e il ricco lo consola di merda, come sanno fare i ricchi, “se me lo dicevi prima…”, “sì ma io sto male adesso”. E non c’è rimedio, non c’è speranza. Jannacci politico, schierato, forse anche perché si porta dietro il destino da migrante, quelle origini balcaniche: per questo a Canzonissima, dove è primo con “Vengo anch’io”, l’inno delirante dell’emarginazione, decide di ripresentarsi con un’altra elegia sul tema, “Quando gli zingari arrivarono al mare”: fiasco totale, precipizio, ma lui trova luce per un’altra delle sue: “Neanche ultimo, penultimo”. Però è vero che non ne fanno più così. Jannacci umano e clown, ma una volta quasi ammazza uno che gli rompe i coglioni, gli va con la mano da chirurgo alla giugulare e stringe, “Lo vedi che stai morendo? Lo vedi? Lo vedi quanto è facile?” e poi lo molla, lo scaraventa indietro, lo grazia. Roba che solo un pagliaccio del Derby dove siedono i boss può fare. Questa invece ve la affido di prima mano, in aereo accanto a lui c’era mio padre e Jannacci si annoia: chiama la hostess: signorina, mi porta un caffè? Signorina ma è freddo. Signorina ma è lungo. Signorina ma è cattivo. Signorina ma c’è dentro qualcosa. Signorina ci voglio il latte. Quando lei è sull’orlo del precipizio, decisa ad aprire il portellone per buttarsi giù, la richiama: “Signorina!”. “Cosa c’è?”. “Niente, gioia, scusami, ti voglio tanto bene”, e le fa una carezza, dolcissima, struggente come San Siro quando i giocatori e i bagarini e i bancarellari sono spariti e anche l’ultimo tram va via nella caligine.