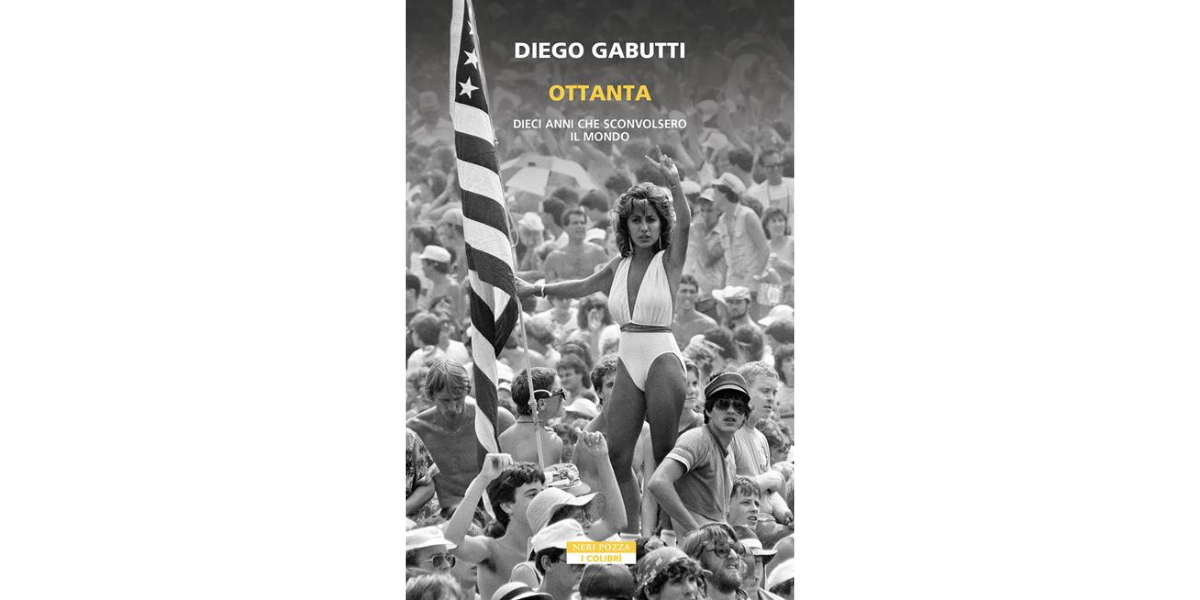Sono due anni che si discute su quale soluzione di pace sia possibile in Ucraina. Proviamo a ricordare alcuni esempi della storia recente. Ci sono almeno cinque guerre di invasione che sono avvenute nel secolo scorso. L’invasione sovietica dell’Afghanistan (1979-1989), l’invasione turca di Cipro (1974), la guerra di Corea (1950) tra la Corea del Nord e la coalizione delle Nazioni Unite, la Seconda Guerra Mondiale e la guerra d’inverno (1939-40) tra Finlandia e Russia.
Scenario 1945
L’Ucraina vince la guerra grazie all’appoggio della coalizione occidentale. Uno scenario oggi molto ottimistico, ma possibile se i Paesi occidentali fossero pronti a supportare l’Ucraina per qualche anno. La Russia, che adesso è in vantaggio, ha però delle fragilità strutturali. È difficile prevedere quanto la sua economia ed il sistema sociale, apparentemente granitico, possano resistere alla lunga. È utile ricordare che la Russia ha perso le ultime guerre che ha combattuto da sola (Guerra Russo-Giapponese e Prima Guerra Mondiale), mentre ha vinto la Seconda Guerra Mondiale soprattutto grazie agli ingenti convogli di armamenti dagli USA e il patriottismo anti-tedesco.
Scenario Afghano
Caso speculare, la Russia sbaraglia l’Ucraina e occupa una gran parte del Paese. In questo caso è molto probabile un prolungamento della guerra sotto forma di guerriglia per molti anni come in Afghanistan. È già successo dopo la seconda guerra mondiale. I soldati dell’armata patriottica ucraina (UPA), che aveva combattuto con i Tedeschi contro l’Armata Rossa, continuarono a combattere i sovietici con un guerra partigiana durata 15 anni. Uno scenario che promette molte stragi di civili e deportazioni da parte degli occupanti russi, e di conseguenza, una ulteriore immigrazione di milioni di rifugiati Ucraini in Europa.
Soluzione coreana
È la formula di cui si parla più spesso, forse perché è quella più familiare al grande pubblico. Appena 5 anni dopo la seconda guerra mondiale, la Corea del Nord, inizialmente incoraggiata dall’’URSS, invase la Corea del Sud, conquistandola quasi completamente. Gli Stati Uniti, guidarono una coalizione internazionale di molti paesi, che sconfisse i nordcoreani e invase il loro territorio, ma fu respinta a sua volta dall’intervento della Cina, che portò il fronte a metà della penisola dove si stabilizzò sul 38° parallelo. Da allora c’è una situazione di pace armata, perché il confine tra le due Coree è fortificato e pattugliato dai rispettivi eserciti con una presenza stabile di truppe americane. Dalla fine della guerra sono avvenuti spesso incidenti armati con morti. Il livello di tensione tra Corea del Sud e Corea del Nord è sempre alto ed impedisce la smilitarizzazione. Gli USA sono un alleato militare fondamentale per la Corea del Sud e il garante della sua sicurezza da attacchi del Nord. Entrambi gli stati, sono riconosciuti dall’ONU, hanno rappresentanze diplomatiche in tutti i Paesi del mondo e partecipano agli eventi internazionali (Olimpiadi, Expo, etc.).
Applicare la soluzione Coreana alla guerra d’Ucraina, significa creare un confine militarizzato e permanente presidiato da truppe di eserciti stranieri, come forza di interposizione. Al momento non ci sono paesi europei o di altri continenti che hanno dato la disponibilità dei loro eserciti per svolgere questo ruolo. La presenza di truppe americane in Ucraina come forza di pace è da escludere, perché una delle ragioni di questa guerra è proprio la volontà di Putin di scongiurare la presenza militare americana in Ucraina. Esiste una ipotesi fantasiosa che vede la Cina come garante del confine, con una fascia di territorio sotto amministrazione cinese, dove poter insediare aziende e creare una base logistica tra Cina e Europa. Se da un lato questo rappresenterebbe una garanzia credibile, perché la Russia rispetterebbe un accordo con la Cina, dall’altro, una presenza economica e militare cinese ai confini dell’Europa, sarebbe uno scenario geopolitico indigesto per la politica estera americana.
Soluzione cipriota
Una guerra di cui si parla poco, seppure avvenuta in tempi più recenti di quella di Corea. Forse perché ci sono meno film e le due Coree sono più presenti nella cronaca di quanto lo sia Cipro. Nel 1974, la Turchia realizzò una “operazione militare speciale” finalizzata a proteggere la minoranza turca dal governo nazionalista greco dell’isola. L’invasione ebbe successo. Le truppe turche conquistarono il 40% dell’isola di Cipro e si fermarono. Si creò un confine armato che tagliò in due l’isola. Nacque una Repubblica di Cipro Nord, sostenuta dalla Turchia, ma non riconosciuta dall’ONU fino ai giorni nostri. Significa che i cittadini ciprioti del nord non dispongono di un passaporto valido per viaggiare, eccetto che in Turchia. Nonostante tutta l’isola sia ufficialmente membro dell’Unione Europea, solo i cittadini della parte greca possono usufruire della cittadinanza europea. Negli anni il confine è stato progressivamente smilitarizzato, e alcuni varchi tra le due nazioni sono stati aperti.
Nel contesto ucraino, questa soluzione significherebbe un cessate il fuoco, senza un accordo di pace, con il non riconoscimento internazionale dell’annessione russa dei territori ucraini occupati. Tutte le attività commerciali e istituzionali nelle aree occupate sarebbero boicottate a livello internazionale (per esempio né aziende straniere, né consolati potrebbero insediarsi in Crimea). Ma l’Ucraina perderebbe questi territori, senza avere in compenso un trattato di pace, con il pericolo di un nuovo attacco perché il conflitto sarebbe congelato, ma non spento. Un po’ come la situazione in Donbas dal 2014. Inoltre, senza un trattato di pace che prometta un assetto duraturo, si rischia di creare una situazione “palestinese”, cioè uno stato di guerra permanente. Ma in questo caso molti Ucraini oggi in Europa sceglierebbero di non tornare al loro Paese per la paura di una riapertura del conflitto.
Soluzione finlandese
Nel 1939, qualche mese dopo l’invasione della Polonia da parte di Hitler, Stalin lanciava la sua operazione di conquista della Finlandia, che vent’anni prima faceva ancora parte dell’Impero russo. Gli andò molto male, perché i Finlandesi opposero una resistenza accanita, proprio come gli Ucraini, e impedirono l’annessione all’URSS. Alla fine la Finlandia si arrese e negoziò la pace, cedendo il 20% dei suoi territori (la regione della Carelia e il porto di Vyborg), in cambio della indipendenza. Inoltre, nella pace riconfermata nel 1944, prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, Stalin impose la clausola della neutralità, cioè la non adesione a nessuna alleanza militare, condizione che fu rispettata dalla Finlandia per tutti questi anni fino al recente ingresso nella NATO. Se nel 1940-1944 aveva perso la guerra, nel lungo termine la Finlandia ha vinto, ottenendo indipendenza, sviluppo economico e democrazia, e potendo anche scegliere di entrare nell’Unione Europea.
La soluzione finlandese sembra quella più adatta alla situazione dell’Ucraina. In pratica, i territori occupati dalla Russia sarebbero come un sacrificio “tipo Carelia” da concedere per avere in cambio un trattato di pace con una garanzia internazionale di sicurezza territoriale. Le condizioni attuali del fronte non lasciano sperare che l’esercito ucraino possa riconquistare i suoi territori occupati. Ma la rinuncia a quelle terre oggi è politicamente inaccettabile per il governo. Ma se si studia la situazione generale, l’Ucraina ha comunque scongiurato la conquista del paese da parte dei Russi. Inoltre, tutte le grandi città ucraine (eccetto Mariupol) sono rimaste sotto il controllo di Kiev. Quindi, l’Ucraina ha vinto, perché la Russia ha fallito i suoi obiettivi strategici: il dominio dell’Ucraina e l’egemonia sul Mar Nero, con la conquista di Odessa. Questo assomiglia molto ad una vittoria “alla Finlandese”.
Quale soluzione giusta per l’Ucraina
Ma anche scegliendo la soluzione finlandese, mancano alcune condizioni necessarie per applicarla:
- La sicurezza territoriale. Chi garantisce la sicurezza dei nuovi confini? Cosa impedisce alla Russia di attaccare nuovamente l’Ucraina qualche anno dopo il cessate il fuoco? Diplomazia americana Europa, e G7, devono trovare una risposta a questa domanda. Sennò si presenta una riedizione del caso dei Sudeti, quando Francia e Inghilterra concessero a Hitler l’occupazione di territori della-Cecoslovacchia, popolate da germanofoni, in cambio della promessa di frenare le proprie ambizioni. Pochi mesi dopo Hitler invase tutta la Cecoslovacchia stracciando l’accordo e Francia ed Inghilterra rimasero ad osservare impotenti. L’Ucraina potrebbe accettare la condizione di neutralità e rinunciare all’ingresso nella NATO (che comunque non è garantito), a condizione di poter comunque ricevere supporto militare ed eventualmente la presenza di forze straniere di peace keeping a garanzia dei confini.
- I piani della Russia. Per la Russia l’Ucraina è molto più importante di quanto la Finlandia fosse per Stalin. La Finlandia era una questione di orgoglio per ripristinare i confini dell’Impero russo. Ma i Finlandesi erano un’osso troppo duro e con la soluzione della neutralità, almeno l’URSS rese sicuro quel confine. Invece la perdita dell’Ucraina per la Russia è un grave affronto. La leadership russa considera ideologicamente gli Ucraini come fratelli minori che non hanno il diritto all’indipendenza, ma devono essere soggetti al loro dominio. Inoltre, l’Ucraina è la culla dell’impero russo. Una pace che riconosca i confini tra i due paesi va contro quello che la propaganda russa afferma da anni.
- La parola di Putin. La cosa che chiedono spesso gli Ucraini è: “come possiamo fidarci di Putin? Lui non mantiene mai la parola. L’ultimo che si è fidato di lui è Prigozhin (leader dell’agenzia mercenaria Wagner, morto in un attentato dinamitardo sul suo volo).” Effettivamente, lo stesso Putin ha spesso contraddetto affermazioni fatte in passato. Occorre trovare un garante esterno che garantisca per il mantenimento degli accordi. La Cina ha questi requisiti.
- Le promesse di Zelensky. Il presidente ucraino dall’inizio della guerra ha promesso al suo popolo che l’Ucraina avrebbe combattuto fino alla riconquista dei territori occupati fino ai confini del 1991 (quindi, Crimea e Donbas inclusi). È stato un messaggio efficace per avere il massimo del consenso e della coesione del paese, ma politicamente imprudente. Infatti, se le vittorie militari del 2022 facevano sperare nella possibilità di riuscirci, oggi questo obiettivo sembra irrealistico. Ma Zelensky ha messo la sua faccia su questi obiettivi, varando perfino una legge che gli lega le mani nei negoziati con Putin. Se cambierà strategia negoziale, pagherà un alto costo politico.
Queste sono le opzioni che i precedenti storici ci mostrano. C’è sicuramente spazio per qualche soluzione diplomatica creativa, ma non si discosterà di molto da uno degli esempi illustrati.
La responsabilità delle scelte per finire la guerra ricade sui grandi attori internazionali coinvolti. Da un lato USA ed Europa, dall’altro la Cina. A Zelensky si presenta la grande sfida di puntare sullo scenario più probabile, finchè ha carte da giocare e di non trovarsi nella condizione di subire le decisioni dei Paesi da cui dipende militarmente e finanziariamente. Gli sarebbe utile leggere la biografia di Carl Gustaf Mannerheim, il geniale leader della resistenza finlandese. Era un generale zarista di origine tedesco-finlandese, che si trovava a Odessa al crollo dell’Impero russo. Aveva visto il cambiamento epocale della rivoluzione russa e aveva sposato la causa dell’indipendenza della Finlandia. Aveva imparato quando fosse il momento di combattere e quando quello di negoziare.