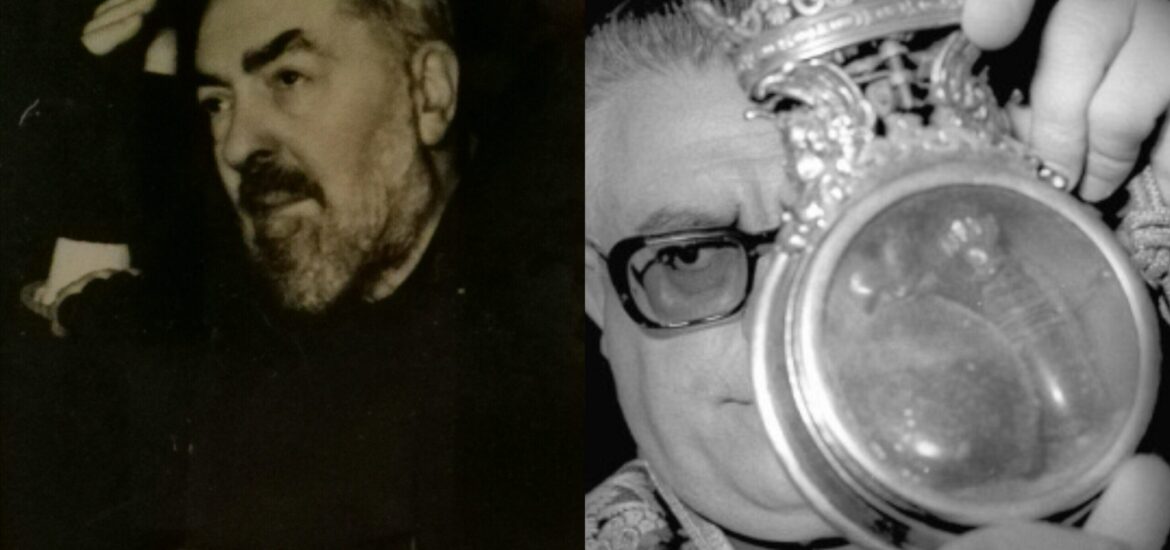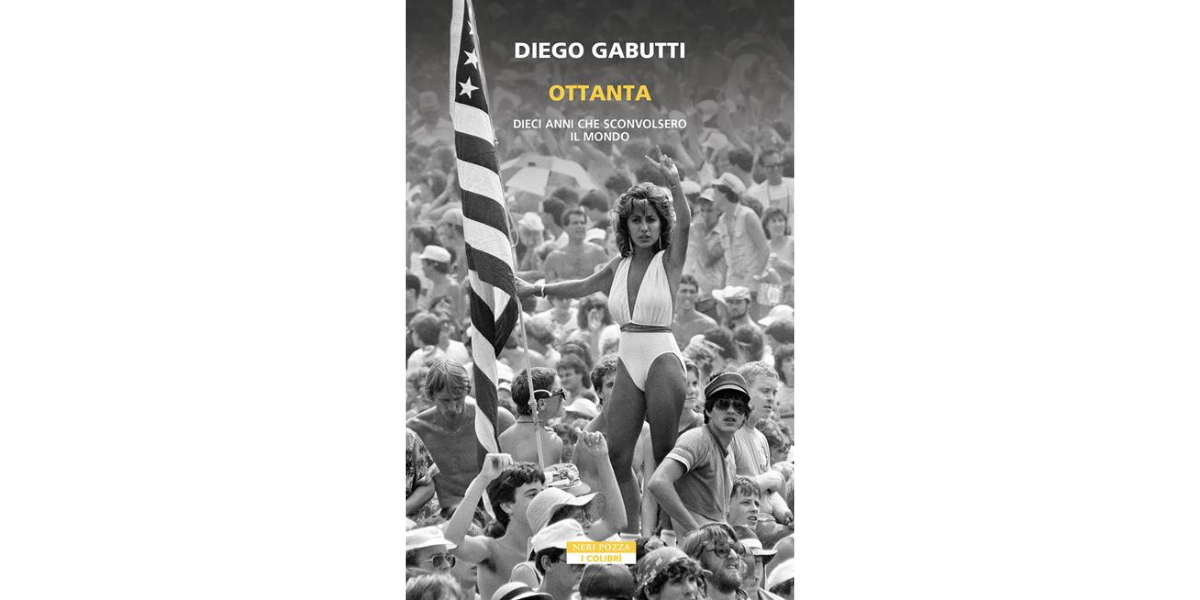Il 20 settembre 1918, in uno sperduto convento del Gargano, padre Pio da Pietrelcina manifesta sul proprio corpo le cinque piaghe di Gesù. Come racconta Sergio Luzzatto in un libro ristampato dalla casa editrice Einaudi nel maggio scorso, l’Italia era allora davanti a un crocevia della sua storia (“Padre Pio. Miracoli e politica nell’Italia del Novecento”, 2007). Al bagno di sangue della Grande guerra si era aggiunta la carneficina dell’influenza spagnola (le vittime stimate furono almeno seicentomila). Il miracolo del “crocifisso vivo” divenne perciò simbolo di una speranza di rinascita del paese e di un’accorata domanda di grazia proveniente dai ceti popolari. Ma suscitò anche una forte diffidenza nell’Italia laica, in un clima politico segnato dalle lotte operaie e contadine del “biennio rosso” culminate nell’occupazione delle fabbriche (1919-1920).
Suscitò anche l’ostilità del Vaticano, contrario alle forme più spinte di religiosità mistica. Fin dagli anni Venti la storia di padre Pio, quindi, si intrecciò strettamente con la storia della Chiesa e con la storia d’Italia. Denigrato da Agostino Gemelli, e quasi perseguitato dai presuli del Sant’Uffizio, il cappuccino con le stimmate trovò potenti difensori all’interno del Partito nazionale fascista. Seguirono decenni di vicende turbolente e perfino rocambolesche, tra conversioni e ritorsioni, pellegrinaggi e sciacallaggi, congiure e abiure, finché l’avvento al soglio pontificio di Pio XII non diede il via libera al culto del frate. Più tardi, Giovanni XXIII scatenò un’ultima offensiva prima che Giovanni Paolo II lo nominasse santo (giugno 2002).
Le stimmate di padre Pio sono un esempio paradigmatico di miracolo (dal latino “miror”, meravigliarsi), ovvero di un evento straordinario che è letteralmente fuori della nostra abituale esperienza. Di qui il suo naturale collegamento con un intervento di Dio nel mondo degli uomini. Sotto questo profilo, il miracolo accompagna da vicino la fenomenologia della religione e ne condivide in qualche modo gli esiti. Può essere espressione di una genuina apertura alla trascendenza e alla rivelazione divina. Ma può anche degenerare in “instrumentum regni” di una politica pronta a sfruttare la credulità popolare per i propri disegni.
Il 14 febbraio 1969 Paolo VI approvò con la “Mysterii Paschalis” il nuovo calendario liturgico universale. La riforma rendeva la memoria del 19 settembre, tradizionalmente dedicata a san Gennaro, obbligatoria e solenne a Napoli, ma facoltativa nel resto del mondo cattolico. Il “declassamento” del santo lasciò di stucco la città. Tuttavia, chi non crede di solito non cambia opinione di fronte alle prove. E chi crede non ne ha bisogno. In ogni caso, i napoletani fanno sempre quadrato attorno al santo. Infatti, alla notizia della retrocessione del miracolo del patrono a “prodigio”, sui muri di Napoli apparve un invito, vergato da una mano ignota, espressione della antica saggezza partenopea: “San Gennà, fottatenne”.