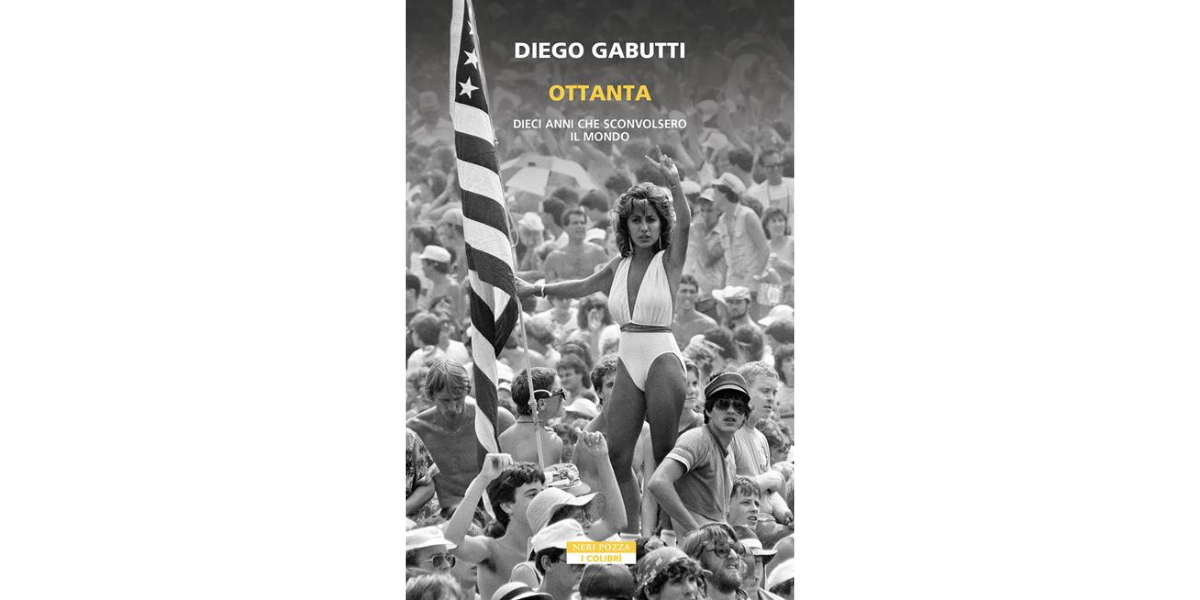Niente di nuovo sotto il sole mediterraneo, euro-africano e globale. Ciò che accade in questi giorni e in questi tempi ripete ciò che è sempre accaduto: occorre quindi capire perché l’argomento migratorio assuma l’attualità dell’“emergenza”, come usiamo dire con un lemma stereotipato.
CHI ALIMENTA L'”EMERGENZA” MIGRAZIONI
Il primo dato che in apparenza giustifica l’esagerazione è numerico: il flusso che muove dal Nordafrica verso l’Italia è aumentato in modo significativo rispetto agli anni scorsi e spesso raggiunge livelli, altro stereotipo, da “record”. Quando anche migliaia di persone si riversino tutte assieme su Lampedusa, però, viene difficile comprendere come possano mettere in crisi una nazione e un’Unione che pretendono di appartenere al mondo più sviluppato.
Chi sostiene l’emergenzialità la motiva con dinamiche quali la crisi economica dell’Africa magrebina e subsahariana, i cambiamenti climatici, l’instabilità politica dell’area (cronica ma in fase acuta) e la ferocia autoritaria e dittatoriale di molti regimi. Chi contesta l’allarme in linea di massima condivide tali constatazioni, rigettando però l’ultima e nodale questione dei “trafficanti” contro cui il governo ha impostato narrativa e azione: le persone avranno pure desiderio di partire, ma prima dobbiamo aiutarle a non farlo, applicando la tolleranza zero verso chi specula ignobilmente, mettendo a repentaglio le vite dei migranti.
Noi comuni osservatori non siamo in grado di pronunciare un parere competente al riguardo, poiché il drammatico percorso che giunge alle destinazioni costiere italiane viene illuminato solo all’approdo, a parte alcuni dossier specialistici che non approdano all’opinione pubblica, e anche l’incontro del presidente Meloni con famigliari e superstiti di Cutro, di grande interesse antropologico, non ha fornito elementi risolutivi. Appare chiaro, però, che qualche volano sta aumentando la cinetica. In Tunisia, per esempio, è noto il circolo vizioso tra stallo socio-economico e tentazione di andarsene delle risorse più giovani e brillanti.
COSA HA FATTO IL GOVERNO MELONI
L’altro fattore che in questo periodo porta a parlare tanto di un fenomeno così stabile è proprio il governo Meloni. Che lo ha sollevato all’attenzione politica non solo interna – come già era capitato in occasione delle leggi Bossi-Fini e Turco-Napolitano, dell’esperienza al Viminale di Matteo Salvini e di Marco Minniti – ma anche delle relazioni europee e internazionali. Che si presenti a un Consiglio Ue o all’assemblea Onu, la presidente del Consiglio dice in modo chiaro, un po’ logorroico e ripetitivo, che non le interessa redistribuire chi arriva ma rallentare gli arrivi, andando a trattare con gli africani. Un leit motiv a cui qualcuno a lei vicino aggiunge che il business migrazioni non è solo economico, che c’è un disegno geopolitico.
La risposta è a dir poco un caos. I vari paesi sono interessati solo a ciò che accade in casa loro, ma lo ammettono in modi e toni contraddittori. Francesi e tedeschi rasentano la schizofrenia: Macron ha fatto smentire le proprie aperture all’Italia dal suo ministro degli Interni Darmanin nell’arco di poche ore; Berlino ha inanellato in rapida successione l’annuncio di chiudere le porte, la solidarietà per l’Italia e l’appoggio alle Ong perché ci portino ancora più migranti. Il Papa e Mattarella alternano le rampogne chiaramente rivolte all’esecutivo in nome del dovere caritatevole con qualche tiratina d’orecchie all’Unione e alla comunità internazionale in nome della condivisione. Le istituzioni europee, specularmente, ci bacchettano quasi sempre e più raramente condividono la nostra posizione (come con una sentenza dell’altroieri). Chi si palesa più convinta in tal senso, come Ursula von der Leyen, probabilmente agisce più per propaganda elettorale che pensando di produrre risultati concreti. Illuminante l’estenuante trattativa con Tunisi, dove la pretesa delle anime belle di non farsi aiutare da paesi che non rispondano pienamente allo screening democratico è addirittura irritante. Certo la colpa non è solo e tutta degli “altri”, l’Italia ha accumulato troppe pratiche inevase e aperte con l’Ue (Mes, Pnrr, Patto di stabilità, etc.) ed è ovvio che la controparte usi i migranti come leva per il braccio di ferro.
LE MACRO-TENDENZE
Neppure le opposizioni riescono a fare coro sul tema: tra Conte, Schlein, Fratoianni e Grillo, anzi, è tutta una stecca. Meloni ha buttato un sasso nello stagno e le onde si vedono. Ma la possibilità che si remi nella stessa direzione è prossima allo zero e quindi vinceranno le macro-tendenze oggettive. L’osmosi tra popolazione, territori e ricchezza disponibile o potenziale, data la sproporzione demografica e reddituale tra Europa e Africa, così come tra Usa e America Latina, si può rallentare solo se la parte più abbiente e meno popolosa attiva poderose macchine da guerra: gli Stati Uniti un minimo ci provano, l’Europa no, poiché è vittima di un pensiero autocritico prossimo al suicidario e non attiva i meccanismi immunitari, non percependo la rivoluzione inoculata per via omeopatica.
I corpi sociali reagiscono più facilmente quando ravvisano una soluzione di continuità come l’attentato alle Torri Gemelle o l’esplosione della pandemia, un momento che separa un prima e un dopo, inducendo a combattere il nemico e provare a rimettere indietro le lancette della storia. Casi simili sono però rari, in genere le cose cambiano nel corso di periodi lunghi, senza che ce ne rendiamo conto immediatamente. Come con le tecnologie, dove pochi saprebbero dire chi abbia “inventato” il cellulare, il computer o come sia nata Internet, al massimo conosciamo coloro che hanno sfruttato commercialmente tali innovazioni, i vari Gates, Jobs, Zuckerberg, Musk. Lo stesso paradossale meccanismo che agisce nella psicologia dell’età formativa, dove un trauma come l’abuso fisico può essere affrontato più facilmente di quello protratto nel lungo periodo, per esempio attraverso l’anaffettività. Ma anche mettersi a dieta, cambiando in modo definitivo le proprie abitudini alimentari, è quasi più difficile che interrompere una dipendenza, che vincola moltissimo ma si sostanzia in un solo comportamento da interrompere.
TRA RIVOLTA E RIFORMA STRUTTURALE
Per questo è più difficile attuare una riforma strutturale che una rivolta. L’energia e le risorse necessarie per un cambiamento di stato immediato sono notevoli ma, una volta reperite, consentono il raggiungimento dell’obiettivo. In un processo riformistico il “fatto!”, la spunta verde, la soddisfazione del risultato non arrivano mai, il lavoro è continuativo e la realtà nel frattempo continua a modificarsi per proprio conto. I processi riformistici sono “non lineari” in quanto, protraendosi nel tempo, l’adattamento evolutivo dell’oggetto si oppone a quello del soggetto. Per questo temiamo che gli sforzi per una regolazione dei processi migratori saranno vani.
Come dicevano alcune femministe di una volta, pensiamo a Ida Magli e Oriana Fallaci, quella migratoria è un’invasione che produrrà l’islamizzazione e la de-occidentalizzazione del Vecchio continente con una modalità soft, attivando un malinteso senso di carità cristiana, molto più efficace di una guerra di religione aperta. Una jihad morbida. Tanto che le femministe progressiste non insorgono, anzi solidarizzano con la discriminazione musulmana, come quando appoggiano il burkini; così come i sindacati hanno accettato il crollo del mercato e della dignità del lavoro operato con il neo-schiavismo dei lavoratori stranieri, venuti a fare i lavori che gli europei non vogliono più fare alle stesse condizioni.