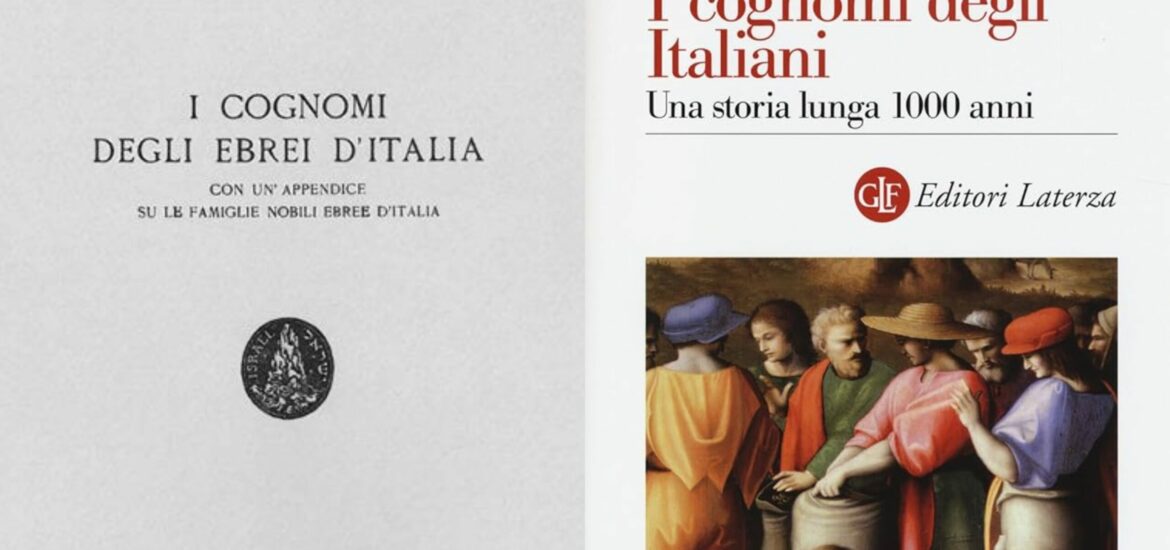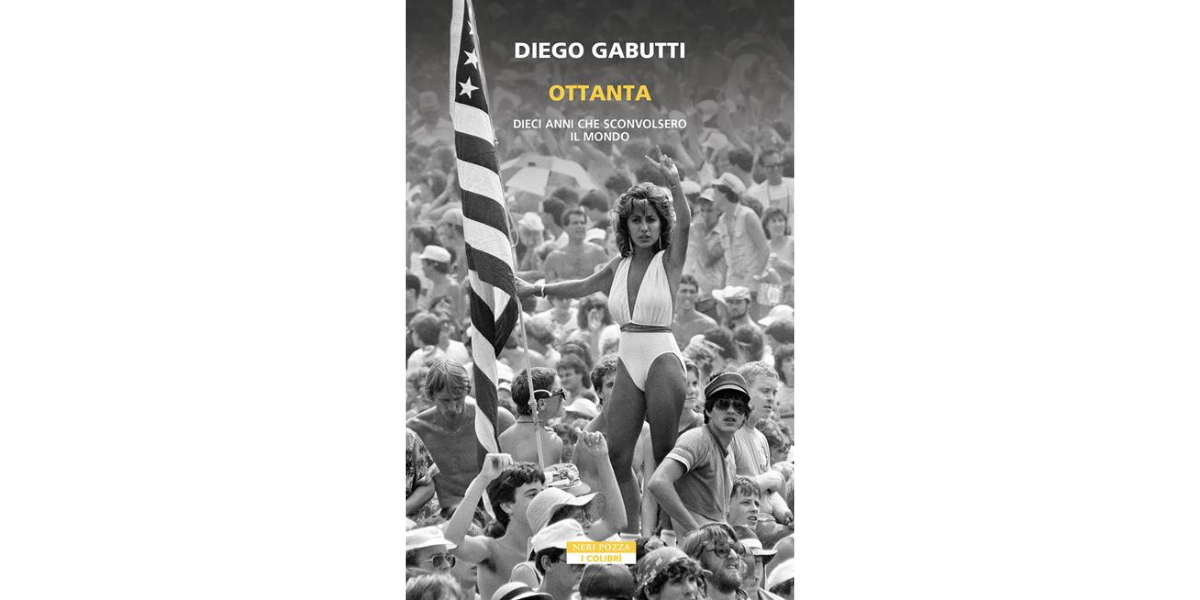Una scena toccante del film di Luigi Comencini “Tutti a casa” (1960), ambientato dopo l’8 settembre 1943, mostra un soldato tedesco che esamina sospettoso i documenti dell’ebrea Silvia Modena, con i compagni della ragazza che cercano di proteggerla fingendo di ignorare l’esistenza di una città con quel nome. Nello stereotipo c’è ovviamente una parte di verità. Fin dal Duecento gli ebrei gestivano il prestito al minuto, stabilendosi così in centri abitati, grandi e piccoli. Data la ristrettezza del patrimonio ebraico di nomi di persona, quando nel corso dei secoli si rese necessario avere dei cognomi, venne naturale assumere quelli dei luoghi di residenza.
Nel 1925 l’ebreo Samuele Schaerf pubblicò a Firenze un libretto intitolato “I cognomi degli ebrei d’Italia”, corredato da un’appendice sulle “Famiglie nobili ebree d’Italia”. Secondo lo storico Roberto Bizzocchi, l’elenco di cognomi ebraici catalogati dall’autore non ha un fondamento storico (“I cognomi degli italiani. Una storia lunga 1000 anni”, Laterza, 2014). La distinzione tra cognomi ebraici e cognomi cristiani, infatti, è a dir poco problematica. Solo alcuni cognomi si possono davvero considerare peculiari dei membri delle comunità ebraiche italiane: per esempio, Coen (sacerdote), Levi (nome anche della Tribù che ottenne dal Signore la primogenitura sacerdotale), Toaff (venditore ambulante o guardia notturna), Gabbai (funzionario della comunità). D’altro canto, nella lista di Schaerf compare curiosamente anche il cognome Rossi, circa il quale non si può dubitare che sia stato e sia tuttora anche quello di non ebrei.
Resta il fatto che l’intento di Schaerf era chiaramente patriottico, quello cioè di rivendicare il contributo offerto dagli ebrei -dal Risorgimento al Primo conflitto mondiale- alla costruzione dello Stato unitario. Nelle pieghe della campagna antisemita lanciata dal fascismo, la sua opera fu invece utilizzata per meglio organizzare la discriminazione e la persecuzione. Il testo di Schaerf venne ristampato con questo nuovo scopo, e, quando furono emanate nel 1938 le leggi razziali, il suo elenco fu incrociato con l’albo dei pubblicisti per dare la caccia ai giornalisti e scrittori ebrei.
La certezza che esistesse un patrimonio antropominico esclusivamente ebraico ispirò la legge del luglio 1939, che espose gli ebrei italiani a una gogna spregevole, creando una sorta di ghetto onomastico. Oltre a una clausola limitativa in materia testamentaria, la legge ordinava “ai cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica […] che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l’origine ebraica, di riprendere l’originario cognome ebraico”. Il nome diventava così un marchio infamante, una specie di sostituto della stella gialla di David reintrodotta dal nazismo (stigma del deicidio e della lussuria, come aveva ribadito solennemente il Concilio Lateranense del 1215). Una crudele e funesta eterogenesi dei fini, di cui purtroppo è cosparsa la storia umana.