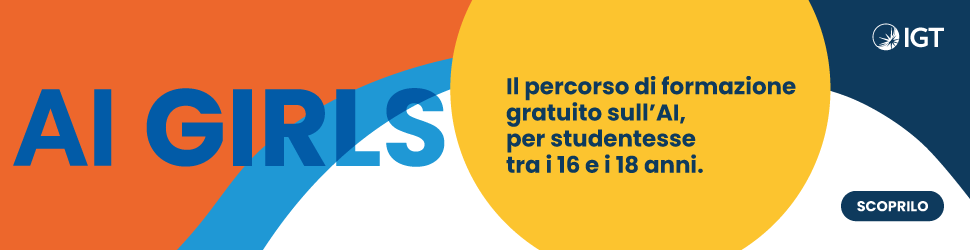L’incidente di percorso sul voto nei confronti del deputato forzista Diego Sozzani non va sottovalutato. Non tanto per il fatto in sé, ma in quanto spia di contraddizioni ben più profonde. I fatti sono noti. La Camera ha respinto (235 si, 309 no, un astenuto) la richiesta della custodia cautelare per il deputato accusato di finanziamento illecito ai partiti. Un “regalo” di 10 mila euro non dichiarato, promesso da un’azienda. Fin qui il misfatto, anche se non è dato di sapere se quella promessa sia stata poi mantenuta. Immediata la reazione di Luigi Di Maio che con le sue parole ha cercato di smorzare il boato che a Montecitorio ha accompagnato l’esito della votazione. Segno di un malessere profondo rispetto agli argomenti identitari, nel segno del giustizialismo, del senior partner della maggioranza.
Per la verità in gioco non c’era solo questo. C’era anche il tema delle intercettazioni telefoniche, dove le posizioni tra le due principali forze di Governo erano su fronti opposti. “Divergenze dichiarate”: come ha confermato Alfredo Bazoli, capogruppo dem in Commissione giustizia. Quindi “nessuna meraviglia di chi si meraviglia”: per riprendere il post del Capo del Movimento su Facebook. Era, infatti, prevedibile che le diversità di posizioni si sarebbero manifestate nel voto dell’Assemblea. Nonostante ciò, le accuse contro la “casta” dei politici sono riprese con un vigore inusitato. Ecco i corrotti che, a differenza del cittadino comune, godono dell’immunità che discende dal loro rango. Che poi il Parlamento sia sovrano nelle sue decisioni è cosa che non conta.
Luigi Di Maio non si rende conto di quanto contraddittorio sia il suo comportamento. Nei giorni trascorsi ha esaltato le regole di una democrazia rappresentativa fino al punto da giustificare il “naturale” – ma così non è – passaggio del Governo da una sponda politica all’atra. Tenendo tuttavia ferma la sua casella principale: vale a dire la Presidenza del Consiglio. Ma quando quelle stesse regole non portano acqua al mulino del Movimento, ecco la levata d scudi. La delegittimazione di un voto che si è espresso nell’alvo delle stesse regole costituzionali. La dimostrazione che il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Discutibile anche la sua seconda osservazione: non è stato “un tema di governo”. E’ “tema di valori”. Altro che autonomia della politica rispetto ad una morale, che ha una sua legittimità, ma anche un diverso terreno dove manifestarsi. Questa la distinzione con i vari talebani. La verità vera, comunque, è un’altra. L’inciampo che si è verificato non può non incidere sulle dinamiche di Governo. Se ne avrà maggiore contezza nelle prossime settimane, quando l’argomento “giustizia” entrerà nel vivo. Ma fin da oggi non si può non notare l’anomala figura di un personaggio che è al tempo stesso Capo politico della sua formazione politica e Capo della delegazione governativa. E’ come se Nicola Zingaretti, segretario del Pd, prendesse il posto di Dario Franceschini. Acquisendo, altresì, come il suo omologo, anche la titolarità di un Ministero.
Nella vecchia Dd, monumento di saggezza politica rispetto alle nuove barbarie, era regola (seppur non sempre rispettata) mantenere distinte le due cariche. In genere il Segretario del partito, non partecipava direttamente all’attività di governo. Tanto meno ne era il capo delegazione. Doveva, infatti, avere le mani libere. Evitare cioè che ogni sua presa di posizione potesse avere un impatto sugli equilibri parlamentari.
Un eventuale voto contrario, rispetto a quanto da lui proposto, poteva, infatti, incidere sulle relative dinamiche. Al tempo stesso l’orizzonte del partito era diverso. Guardava oltre l’immediata congiuntura nel tracciare quelle strategie che richiedevano il tempo necessario.
Aver, invece, confuso i diversi piani, come nel caso dei 5 stelle, comporta un pedaggio da pagare. Ne evidenzia la debolezza non solo organizzativa. Ma la mancanza di un respiro culturale effettivo: l’unico in grado di proiettarne l’azione oltre la singola legislatura. Difficile dire se Luigi Di Maio sia consapevole di questi limiti. La sua reazione dimostrerebbe il contrario. “Oggi – ha tuonato – chi ha votato contro l’arresto di Sozzani dovrebbe risponderne davanti all’opinione pubblica. E invece a causa del voto segreto, non ne risponderà davanti agli italiani. Il voto segreto va abolito. Ognuno deve assumersi le sue responsabilità.” Sembrerebbe quindi che per rendere più stringente il controllo da parte del Capo su suoi deputati (anche qualche 5 stelle, a quanto sembra, si è pronunciato per il no) sia questa (l’abolizione del voto segreto) la sua prossima mossa. Non è una cosa da poco.
Il voto segreto, fortemente limitato dai Regolamenti parlamentari, ha un suo fondamento costituzionale, che deriva dall’articolo 67 (“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”). Volerlo abolire significa, in definitiva, trasformare il singolo membro del Parlamento in un semplice “portavoce” dei cittadini. Come insistono da tempo i 5 stelle. Qualcosa – torniamo a bomba – che ha nulla a che vedere con la democrazia rappresentativa. L’idea del portavoce è infatti un’astrazione inconsistente. Si può essere “portavoce” di un singolo gruppo, farsi carico di rappresentare gli interessi dei propri deleganti, ma rappresentare i “cittadini” nella loro interezza è solo un’affermazione priva di senso. Anche perché presuppone un ambiente completamente omologato. Forse l’incubo di George Orwell, nella sua dura critica al totalitarismo. Ed allora “No grazie”: meglio tenerci il voto segreto, pur con tutti i suoi inconvenienti.