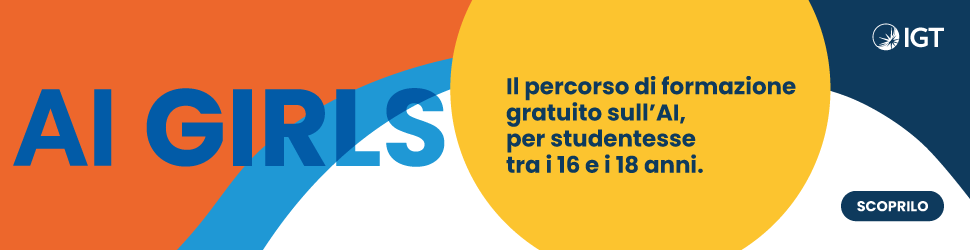La battaglia di Baghouz è finita sabato, e l’ultimo pezzo dello Stato islamico è stato sgominato. “Le Forze Democratiche Siriane – ha scritto su Twitter l’altro ieri Mustafa Bali, portavoce delle Sdf – dichiarano l’eliminazione totale del cosiddetto califfato e la sconfitta territoriale al 100% dell’Isis”.
Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS
— Mustafa Bali (@mustefabali) March 23, 2019
L’annuncio arriva dopo settimane di combattimenti durissimi ma intermittenti. Cominciata più di un mese fa, l’offensiva per riconquistare l’ultimo fazzoletto di terra controllato dagli islamisti è stata ritardata più volte per consentire a decine di migliaia di civili di uscire da Baghouz e a tantissimi combattenti di disertare. Sono quasi settantamila gli uomini e le donne consegnatisi tra febbraio e marzo alle Sdf, che hanno separato gli uomini dalle donne e dai bambini trasferendo questi ultimi nel campo profughi di al-Hol, dove stazionano in condizioni difficili e in attesa di conoscere il loro destino.
Con la vittoria in tasca, l’operazione Inherent Resolve – la coalizione internazionale assemblata quattro anni e mezzo fa dagli Usa che ha condotto la campagna di bombardamenti contro l’Isis – può notificare via Twitter tutto il proprio orgoglio: “La fine del cosiddetto califfato fisico – è l’affermazione del comandante generale della coalizione, tenente Paul LaCamera – è un risultato militare storico (realizzato dalla) più grande coalizione della storia”.
“The end of the so called physical caliphate is a historic military accomplishment that brought together the largest Coalition in history, but the fight against Daesh and violent extremism is far from over.” – LG Paul LaCamera, CJTF-OIR commanding general https://t.co/1njsyDBUQt
— Inherent Resolve (@CJTFOIR) March 23, 2019
Già mercoledì, Donald Trump aveva esternato tutta la propria soddisfazione per il successo ottenuto dai militari. Parlando ai reporter dal prato della Casa Bianca, dove lo attendeva in moto l’elicottero presidenziale Marine One, il presidente aveva esibito ai reporter due mappe (che poi diffonderà dal suo profilo Twitter) della Siria e dell’Iraq che mostrano i territori controllati dai jihadisti all’inizio del suo mandato e oggi.
President Trump: "This just came out 20 minutes ago. So, this is #ISIS on Election Day, my Election Day, and this is ISIS now. So, that's the way it goes." pic.twitter.com/YshPIbyBfz
— CSPAN (@cspan) March 20, 2019
Here’s the ISIS territory map pic.twitter.com/dc5TtvZUHa
— Jordan Fabian (@Jordanfabian) March 20, 2019
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1108479818000224256
“Allora – ha spiegato Trump – questa è la mappa (risalente) alla notte delle elezioni del 2016. Tutta la parte rossa è Isis. Quando ho assunto l’incarico era un disastro. Ora (…) non c’è più rosso. Di fatto, c’è un piccolo puntino, che sarà sparito stasera”.
Quando i giornalisti gli hanno chiesto se gli Usa avrebbero ritirato tutte le truppe dalla Siria, come promesso da Trump il 19 dicembre, la risposta è stata: “No, no. Siamo in Siria, lasceremo duecento uomini lì, e altri duecento in un altro posto in Siria vicino ad Israele per un certo periodo di tempo”.
È la conferma dei piani del Pentagono che, colto di sorpresa dall’annuncio decembrino del commander in chief, avevano brigato per una correzione di rotta e ottenuto da un presidente riluttante di mantenere in Siria una presenza residua di quattrocento militari, metà dei quali schierati nella Siria nordorientale e l’altra metà nella base di al Tanf, al confine con Iraq e Giordania.
Da settimane gli Usa stanno cercando di convincere gli alleati occidentali a posizionare in Siria dei propri uomini a presidio dei territori liberati dalle grinfie dell’Isis. Lunedì a Washington c’era il ministro della difesa francese, Florence Parly. Come riferisce Reuters, la sua missione era cercare di ottenere informazioni sul piano americano di costituire una safe zone nella Siria nordorientale.
L’America spera che Francia, Gran Bretagna e altri membri europei della coalizione mettano a disposizione da 800 a 1.500 uomini. Finora, però, la proposta di Washington ha suscitato parecchio scetticismo. Parigi – che ha già sul terreno, tra Siria ed Iraq, 1.200 soldati – è tra i partner più perplessi.
C’è molta confusione sui cieli del Siraq e ombre cupe si allungano sulla vittoria di sabato. Una di queste la illustra l’inviata del New York Times Rukmini Callimachi: il califfo Abu Bakr al-Baghdadi sarebbe vivo.
La prova arriva tramite un file audio di 44 minuti del misterioso portavoce dell’Isis, Abu Hassan al-Muhajir, diffuso lunedì su Telegram, il canale di comunicazione preferito dal gruppo. Muhajir rompe un silenzio durato quasi sei mesi per sbeffeggiare la pretesa degli Usa di aver liquidato il proprio nemico e per chiamare i musulmani del mondo a vendicare l’attentato terroristico contro le due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda.
Muhajir è il nome di battaglia di un militante di cui non si conosce la vera identità né la fisionomia. Non è mai apparso né in fotografie né nei video prodotti dall’Isis. Nulla si sa della sua biografia. Ha rilasciato finora nel corso del 2018 due dichiarazioni audio, l’ultima delle quali – lo scorso settembre – di appena quattro minuti.
Nel file diffuso lunedì, Muhajir giura che il califfo è ancora vivo e vegeto. “Possa Dio preservarlo”, dice il portavoce con un’espressione usata dai musulmani per riferirsi a persone viventi. Nella parte finale dell’audio, Muhajir fa capire di avergli appena parlato. E riporta un suo suggerimento ai combattenti legato alla necessità di non diventare bersagli della potente coalizione occidentale: “Un consiglio dal califfo dei credenti che riguarda gli strumenti di comunicazione: siate prudenti, prudenti con questi strumenti, anche se ciò allunga il vostro lavoro da due a sette giorni”.
Per ridicolizzare i successi degli avversari, Muhajir rievoca la visita lampo fatta da Trump ad una base Usa in Iraq il 26 dicembre scorso. A quel tempo, il presidente definì “sad” le imponenti misure di sicurezza tra cui ebbe luogo quella visita, sottolineando quanto tutto ciò fosse paradossale dopo che l’America ha speso 7 trilioni di dollari per stabilizzare il Medio Oriente. Un ottimo motivo, per Muhajir, per infierire: “Quanto è strano per un vincitore che non può nemmeno annunciare pubblicamente una visita ufficiale in un paese alla quale si pretende di aver portato pace e stabilità. Non poteva che venire come un ladro impaurito e codardo”.
La mossa propagandistica del portavoce del califfo mette in luce una realtà che gli americani più sobri hanno assimilato da tempo: la vittoria di Baghouz non pone fine alla minaccia dell’Isis. Robert Burns dell’Associated Press spiega uno dei motivi per cui non è il caso di gioire: “Se la storia fornisce una guida, la riconquista del territorio dell’IS può mostrarsi come una vittoria di breve durata se l’Iraq e la Siria non risolvono il problema che ha consentito a suo tempo l’ascesa del movimento estremista: governi che mettono i gruppi etnici o settari l’uno contro l’altro”.
Burns ricorda il monito dell’architetto del piano occidentale per sconfiggere l’Isis in Siria ed Iraq, il generale dell’Esercito Usa Lloyd Austin. Che, nel 2015, mise il dito sulla piaga sottolineando come i soldati sunniti iracheni si erano rifiutati di combattere per il proprio governo durante le travolgenti avanzate dell’Isis. “Hanno permesso – e in certi casi facilitato – la spinta dell’Isis attraverso il paese”, disse allora Austin.
La ragione di questo comportamento è stata ampiamente evidenziata dagli analisti: la totale sfiducia dei sunniti nei confronti dell’operato dell’allora primo ministro sciita Nouri al-Maliki, artefice di una condotta discriminatoria e punitiva nei confronti della minoranza sunnita e, dunque, del risentimento di quest’ultima.
Un problema irrisolto, che spinge Charles Lister, senior fellow al Middle East Institute e autore del saggio “The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency”, che sta per materializzarsi in Siria ed Iraq lo spettro di un Isis 2.0.
L’analisi di Lister, apparsa sulle colonne di “Politico”, è impietosa: l’Isis del futuro potrebbe essere più grande e peggiore di quello che abbiamo visto in azione negli ultimi anni. Per limitarsi al solo Iraq, ci sono 20 mila detenuti dell’Isis e decine di migliaia di simpatizzanti relegati in squallidi campi di detenzione sotto l’occhiuta sorveglianza di forze di sicurezza ostili. A questi si aggiungeranno nelle prossime settimane altri ventimila militanti e loro familiari di nazionalità irachena attualmente custoditi in Siria.
Come se non bastasse, in Iraq ci sono decine di migliaia di bambini “figli dell’Isis” che sono in un limbo giuridico perché Baghdad si rifiuta di produrre per loro i certificati di nascita. Ciò significa, sottolinea Lister, che in Iraq ci sono all’incirca centomila persone che hanno legami con l’Isis: una bomba a orologeria.
(Estratto da Taccuino estero a cura di Marco Orioles pubblicato su Policymakermag.it, qui la versione integrale)