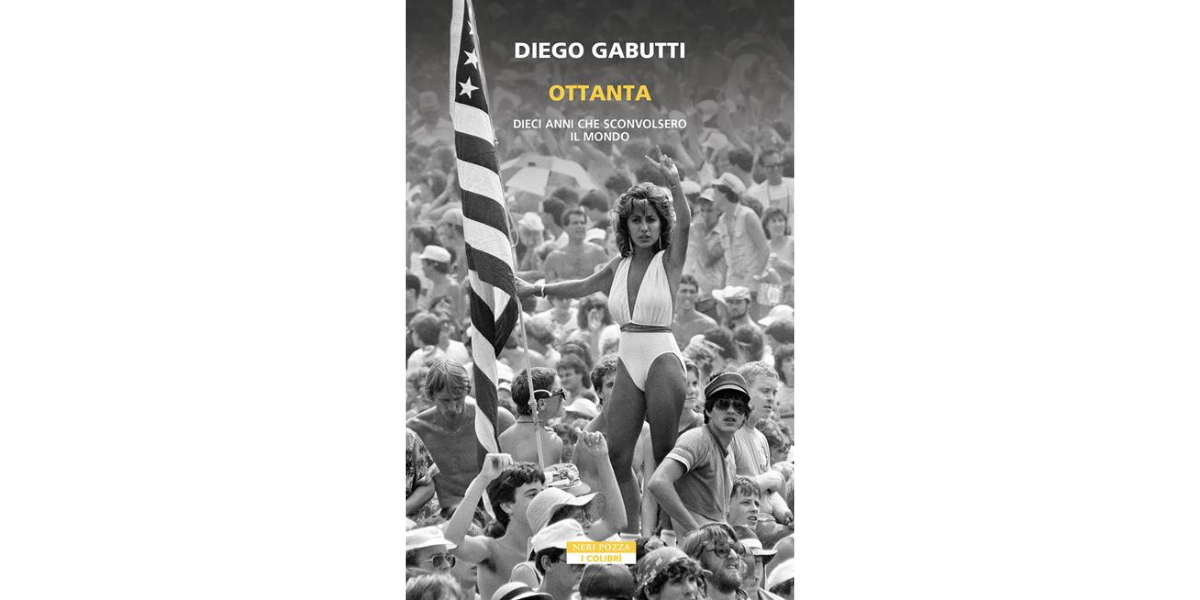Al di là del giudizio specifico sulle singole priorità indicate – dall’ambiente alla competitività, dalla ricerca alla sicurezza – dalla lettura di Europe’s Choice, il programma politico presentato a Strasburgo da Ursula von der Leyen, affiora la presa d’atto, consapevole o meno, di una svolta di lungo periodo che coincide con l’esaurirsi simultaneo di due grandi cicli che hanno caratterizzato gli ultimi decenni.
Emerge, innanzitutto, il radicale cambiamento di priorità in quel trilemma di Rodrik che era di gran moda citare fino a qualche anno fa: fra globalizzazione, sovranità e democrazia ne puoi avere al massimo due, a scelta, su tre. Un trilemma che, almeno alle nostre latitudini, si risolveva in realtà in una dicotomia, essendo la democrazia tecnicamente ineliminabile ed in pratica ampiamente aggirabile, attraverso meccanismi normativi o di semplice agenda setting transnazionali.
Se fino ad anni recenti, infatti, l’elemento irrinunciabile era la globalizzazione, e l’Unione Europea ne era a tal punto coinvolta da aver a lungo sacrificato il mercato interno sull’altare della competitività internazionale, ora le cose sembrano essere cambiate e la sovranità sembra prendere il posto di una globalizzazione sulla cui bara l’ombra di Donald Trump minaccia di piantare l’ultimo chiodo.
C’è, nel documento, una inedita enfasi sulla difesa, la sicurezza interna, la difesa dei confini, la cybersecurity, perfino la suggestione di una polizia europea, riassunta nel perentorio “guarderemo a tutte le policy attraverso la lente della sicurezza”, e nella quale la narrazione sovranista, anziché contrastata come nelle intenzioni dichiarate, appare quasi traslata al livello continentale.
E’ un approccio che trova eco anche, e soprattutto, nella politica economica, impostata anch’essa, appunto, “attraverso la lente della sicurezza”: controllo e monitoraggio degli investimenti in entrate e in uscita, export control, accorciamento delle supply chains, priorità agli approvvigionamenti energetici, di materie prime, di tecnologie considerate vitali. Espressioni come “sicurezza economica”, “protezione dell’economia” e “politica estera economica” ricorrono, e rendono l’idea di quanto si sia ormai idealmente lontani dall’epoca dei mercati globali.
Dal mercantilismo che ha caratterizzato gli anni successivi alla crisi finanziaria – quelli dei surplus commerciali record, tedeschi e non solo, e di un’area euro che sembrava volersi trasformare in una seconda Cina, con tutta l’instabilità interna e la conflittualità esterna, anche fra alleati atlantici, che quell’approccio ha portato con sé – quasi si sfocia in un nuovo tipo di mercantilismo, buffamente sospeso fra militarismo ed ecologia, il cui obiettivo non è più quello di accumulare avanzi commerciali ma autonomia strategica e potere negoziale in sede di politica estera nei confronti di rivali e partner. Due mercantilismi che sono uno il contrario dell’altro: se il primo presupponeva l’apertura dei mercati, il secondo ne richiede, e produce, la sempre più rigida segmentazione.
Ed è proprio nel campo della politica economica che compare la seconda grande novità. Anzi scompare, perché si tratta di un’assenza: quella dell’ossessione per i conti pubblici che ha rappresentato, da Maastricht in poi, il tratto forse più caratterizzante della politica europea, oltre che il maggior terreno di scontro fra Paesi, con vicende troppo note per doverle richiamare. Incredibilmente per chi è abituato a compulsare documenti bruxellesi non se ne parla affatto, se non per un fugace cenno alla sostenibilità di bilancio, inserito in un lungo elenco residuale di generiche sfide da affrontare.
Anche in questo caso, si tratta dell’esaurirsi di un ciclo, quello della “fiscalizzazione della politica”, intesa nell’accezione anglosassone di centralità della politica di bilancio nell’ambito dell’azione di governo. E’ una fase pluridecennale – la seconda del dopoguerra, dopo quella dei glorious thirties, il trentennale compromesso socialdemocratico dell’epoca della ricostruzione e del boom, estinta con la crisi di Bretton Woods e quella petrolifera – che ha preso il via con l’austerity degli anni ’70 ed ha conosciuto il suo zenit negli anni della crisi dei debiti sovrani.
Nel programma di von der Leyen non compare praticamente nulla di ciò che l’ha caratterizzata: le regole di bilancio capziose, l’onnipotenza dei ministri dell’economia, il ruolo ipertrofico delle banche centrali, la sacralità dei mercati finanziari che, anzi, da severi e temuti giudici della virtù dei governi diventano, in questa nuova impostazione, utili strumenti per convogliare il risparmio privato verso gli investimenti nei settori strategici.
Tutto svanisce per far posto, ed è qui che la fine di questo secondo ciclo si interseca con quella del primo, al riemergere della centralità delle funzioni più classiche dello Stato, dalla sicurezza agli esteri e alla difesa, in una potenziale nuova fase strutturale in cui le strutture core dello Stato riguadagnano la centralità ceduta a lungo alle tecnocrazie finanziarie interne e sovranazionali.
Siamo, probabilmente, solo agli inizi di una lunga stagione e l’esito di questa nuova prospettiva dipenderà da come la si saprà declinare. Potrà essere positivo se si tornerà a focalizzarsi sul mercato comune come traino endogeno dell’economia. E sugli investimenti, che sono stati la grande vittima della stagione dell’austerity.
Ma ciò richiede un grado di coinvolgimento dei cittadini, attraverso la rappresentanza democratica ed il libero mercato, i migliori antidoti naturali alla conflittualità politica, commerciale e militare, che rimane incompatibile con approcci rigidamente dirigisti.
Diversamente il rischio è che, dopo esserci a lungo scagliati contro globalizzazione ed austerity, ci ritroveremo a rimpiangere entrambe.