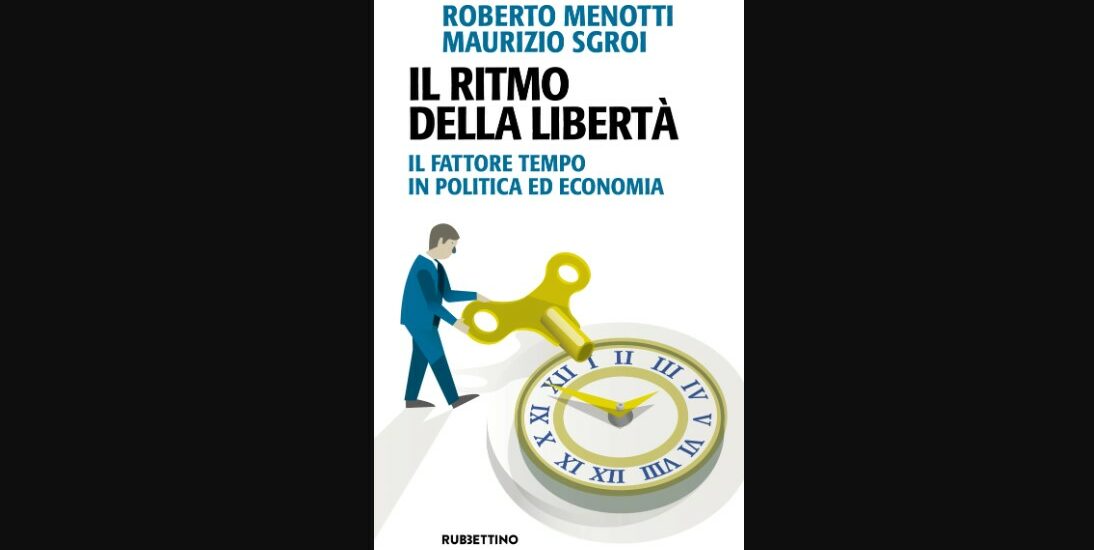Fra futuro potenziale e passato sostanziale – scrivono i due autori – viviamo l’eterno presente dell’attimo che è la nostra vita. Ma, per riuscire a vivere agendo e non solo subendo la realtà, dobbiamo imparare a usare il tempo. Gestire bene il tempo è la chiave per vivere.
Ed è la chiave di questo libro, per molti versi affascinante.
Affascinante nelle sue singole affermazioni e perfino divagazioni.
Perché la tecnica, sulla scorta di una scrittura molto felice e di un approccio che pesca fra discipline e autori molteplici, mi pare esattamente questa: offrire al lettore una serie di stimoli anche molto diversi fra loro, ma che aiutano tutti a pensare, a riflettere e a immaginare il futuro. E quindi a fare proprio quello che qui si propone: usare bene il fattore tempo per trovare un modo nuovo con cui guardare alla realtà. Il libro è scritto, insomma, nel modo in cui Roberto Menotti e Maurizio Sgroi vorrebbero che imparassimo a ragionare.
È prima di tutto una lezione di metodo.
La società istantanea di oggi, spiegano gli autori, ha azzerato la profondità del tempo. La memoria è stata sostituita da una patologica nostalgia del passato, che conduce al regresso; le possibilità del futuro sono state soppiantate da paure millenaristiche o almeno in parte infondate. Il progresso – questa la loro tesi – resta invece il futuro più probabile, se diamo tempo alle sue possibilità di dispiegarsi.
Il tempo è insomma il nostro compagno di viaggio, nel senso che dobbiamo assecondarlo. Andando a tempo – queste le conclusioni del libro – sperimentiamo il ritmo della libertà, l’unico che dovremmo perseguire, e creiamo il nostro futuro. Non serve nient’altro per affrontare l’avventura della nostra vita.
Affascinante, vero?
Ma vediamo un po’ meglio. Il libro spiega in che modo la nozione biblica del tempo, descritta nella prima parte, è stata poi superata; e come ciò abbia permesso di cogliere il ruolo di questa variabile come una sorta di principio attivo e non soltanto come strumento di misurazione.
Superare la nozione biblica del tempo ha significato anche fare un esercizio di immaginazione e creatività, che consente di combinare i molti pezzi del puzzle della vita umana.
In questo racconto di Menotti e Sgroi, in questo viaggio nel tempo, geologia, biologia, evoluzionismo, pensiero sociologico, politico, economico, si mescolano. E il cerchio si chiude: il tempo profondo, scrivono gli autori, ci costringe a fare i conti con la nostra piena appartenenza al mondo fisico. Se usi il “tempo profondo”, cambia anche il tuo approccio alla realtà. Facciamo un esempio: quella che gli analisti politici e finanziari chiamano spesso “volatilità” diventa un tratto fisiologico, non una patologia. Lo stesso vale per la proliferazione di “cigni neri” che in realtà non lo sono (certamente non lo era una pandemia largamente annunciata). E non è affatto sorprendente, usando il fattore tempo, la competizione fra la potenza ancora dominante in molti campi, gli Stati Uniti, e la Cina sfidante. Paese, quest’ultimo, cui tendiamo ad attribuire uno sguardo temporale lunghissimo ma che in realtà sta vivendo una sua attuale “trappola” dello sviluppo.
Uno sguardo più equilibrato, grazie all’uso del tempo profondo, deve anche essere applicato alla questione della lotta al cambiamento climatico. È vero che azioni di mitigazione tardive aumentano costi e rischi degli eventi climatici: in questo caso, il tempo è una funzione della sicurezza.
Ma è anche vero che una strategia come quella disegnata dall’UE – target temporali rigidi, senza risorse comuni per attuarli – rischiano di generare proteste tali da indebolire, invece che rafforzare, il processo di transizione energetica.
Il climate change rientra tipicamente nelle questioni di gestione del rischio e questo libro riguarda ampiamente il problema: che si tratti di transizione energetica, di intelligenza artificiale, di de-globalizzazione, di movimenti demografici, adottare un approccio interdisciplinare, avere fiducia nella neutralità tecnologica, credere nelle opportunità del futuro e non solo temere il futuro, puntare su soluzioni creative, è un modo per evitare la trappola del regresso. Per affrontare con coraggio e fantasia i rischi del XXI secolo.
In conclusione, scrivere di tempo significa – per Menotti e Sgroi – scrivere del progresso e dei suoi nemici, ossia di un concetto di per sé controverso e complicato. Viviamo in una fase storica che sembra caratterizzata dai limiti al progresso.
Limiti di sostenibilità ambientale, frammentazione del quadro internazionale, ennesima “crisi del capitalismo”, dubbi sulla tenuta dei sistemi democratici: sono tesi che per gli autori riecheggiano atteggiamenti fideistici, peccano di pessimismo e di mancanza di immaginazione. In generale, la cosiddetta “politica della paura” rischia di essere una profezia che si autoavvera, facendo emergere istinti di chiusura e perfino di ostilità verso tutto ciò che è nuovo e diverso: in breve, il pericolo da cui questo libro mette in guardia è quello di una nostalgia irrazionale, a sua volta anticamera del “regresso”.
Le “policrisi” e il senso di un caos fuori controllo sono, a parere dei due autori, percezioni e interpretazioni, prima ancora che dati oggettivi. In realtà, esistono elementi concreti e importanti di crisi – almeno in parte non trattati nel libro.
Ma il messaggio interessante è psicologico e politico, prima ancora che analitico: sono elementi che vanno sottoposti a un vaglio attento e in parte confutati, per non soccombere al panico. Sempre continuando con i fattori psicologici, la mancanza di fiducia in sé delle democrazie liberali finisce per diventare a sua volta una fonte di debolezza. E sono le debolezze e le potenziali divisioni interne al mondo democratico che gli sfidanti autoritari cercano di sfruttare. Fino a oggi senza riuscirvi più di tanto.
Come notavo all’inizio, l’approccio di Menotti e Sgroi è fortemente interdisciplinare, partendo dalla convinzione che servono discipline “incrociate” per analizzare sicurezza ed economia, istituzioni e fenomeni sociali, tecnologia e regole giuridiche. Per la ragione molto semplice che viviamo in sistemi strutturalmente “complessi”. È una convinzione condivisa dalla rivista «Aspenia», che ormai da molti anni adotta e in qualche modo sperimenta su una varietà di temi proprio un’impostazione interdisciplinare.
Soltanto il futuro potrà dirci se il testardo ottimismo degli autori sia giustificato, ma intanto vale la pena di leggere le pagine che seguono. Certamente non tutti i lettori saranno d’accordo sulle risposte che vengono fornite, ma le domande su cui si articola il libro sono essenziali: per il tempo della nostra vita e per il tempo che verrà.