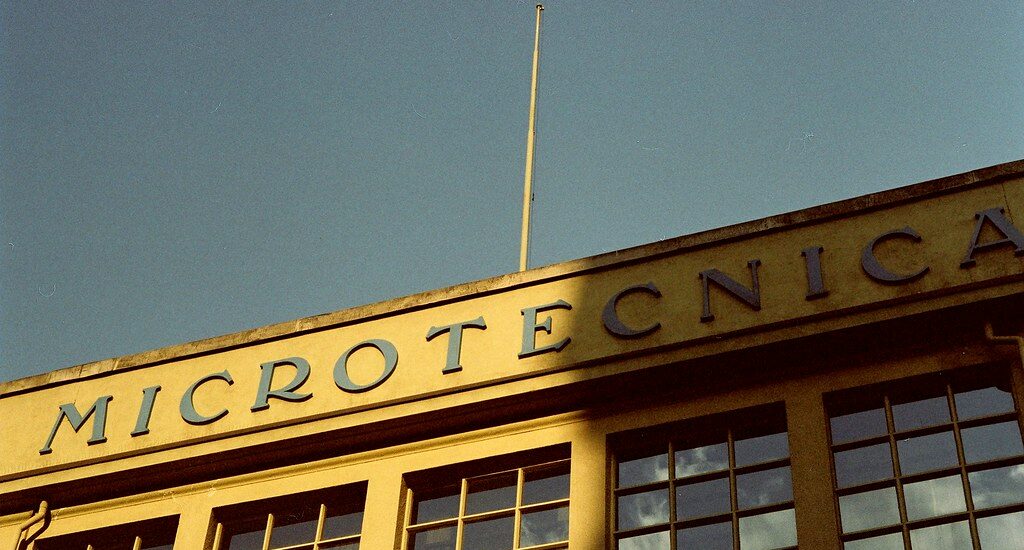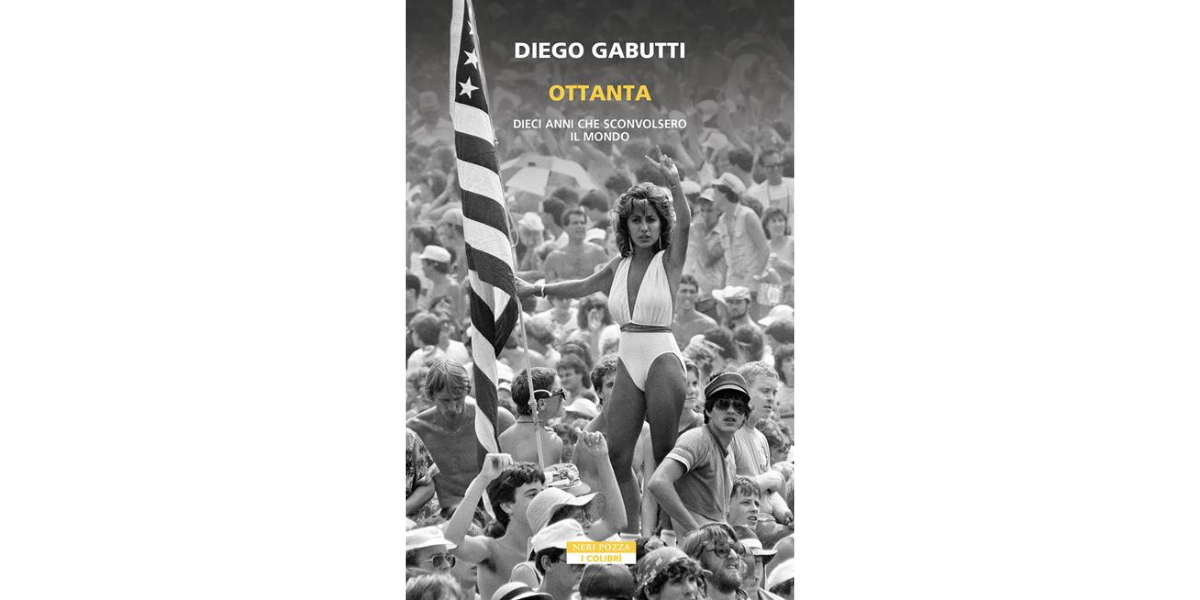Il governo italiano ha utilizzato il golden power per opporsi alla vendita dell’ex-Microtecnica, azienda di meccanica di precisione con sede in Italia ma controllata interamente dalla compagnia statunitense Collins Aerospace, alla società francese Safran. Si tratta di una “scelta delicata” da parte dell’esecutivo di Giorgia Meloni, ma “non è di certo la prima volta” che Roma e Parigi si ostacolano su questioni industriali, spiega Luca Picotti, avvocato e autore del saggio La legge del più forte. Il diritto come strumento di competizione tra Stati (qui la recensione), in una conversazione con Startmag.
Era prevedibile un intervento del genere del governo nel settore Difesa?
L’esercizio concreto dei poteri speciali, rispetto al totale delle operazioni che vengono notificate, rimane circoscritto ad una serie limitata di casi, seppure sia registrabile una marcata crescita negli ultimi anni. Dopodiché, la difesa e la sicurezza nazionale, previste all’art. 1 della legge sul golden power, rappresentano la dimensione più sensibile della disciplina, tale da sfuggire pure alle rigidità dei Trattati europei in tema di libertà di circolazione dei capitali e stabilimento: l’art. 1 ci dice che possono essere bloccate anche le operazioni intra-comunitarie. E non è un caso che il primo veto dall’introduzione del golden power (d.l. 21/2012) abbia riguardato un’operazione sensibile per gli interessi della Difesa promossa da una società europea.
Qual è stato il primo caso di golden power nel settore Difesa?
L’opposizione all’acquisto di Next Ast da parte del gruppo francese Altran nel 2017. Nel 2022 circa il 18% delle notifiche giunte al governo, e rientranti nell’ambito di applicabilità della normativa, ha avuto ad oggetto operazioni nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; in generale, trattasi dunque di una fetta importante, che ha condotto a diversi interventi – seppure, lo si ricorda, comunque limitati e in ottica di extrema ratio – tra imposizione di prescrizioni e vere e proprie opposizioni. Si pensi ad esempio, tra i casi più recenti, al blocco postumo dell’acquisizione di Alpi Aviaton S.r.l. da parte della società Mars (HK) lnformation Technology Co. Limited.
La Reuters ha notato che un intervento che blocca un’azienda europea, in specie francese, è piuttosto raro. È esatto?
È sicuramente una scelta delicata. Da un lato, per ragioni politiche: di norma, i poteri speciali sono riservati a realtà considerate ostili o concorrenti, come la Cina, non a soggetti riconducibili a paesi alleati, con cui una integrazione a livello strategico, tecnologico e industriale dovrebbe essere, in linea teorica, ben vista. Dall’altro, perché si rischia di violare i principi europei. Seppure in transizione e in parte de-legittimata dai paradigmi emergenziali di questa fase storica, l’infrastruttura giuridica comunitaria rimane un grande ostacolo all’esercizio dei poteri speciali in operazioni intra-europee. Detto questo, va anche sottolineato che non è di certo la prima volta che Roma e Parigi si mettono i bastoni tra le ruote.
In quali altri dossier industriali Italia e Francia di recente hanno battagliato?
Prima accennavo al veto nel 2017 all’acquisizione di Next Ast. da parte della francese Altran. Sempre lo stesso anno, vi è stato il controverso intervento governativo, tramite prescrizioni, nella vicenda Tim-Vivendi. Nello medesimo periodo è saltata l’operazione tra Fincantieri e Chantiers de l’Atlantique per l’improvvisa nazionalizzazione di Stx da parte dello Stato francese. Da ultimo questa opposizione a Safran. In un paragrafo del mio libro La legge del più forte mi dedico proprio a questa rivalità italo-francese passando in rassegna i diversi casi di frizione tra i due paesi. Dunque, è certamente un profilo delicato; è senz’altro più raro rispetto ad un blocco di una operazione con controparte cinese. Ma non è impossibile, anzi.
Secondo lei, c’era già un’intesa di massima tra francesi e americani, anche tra alte sfere politiche, istituzionali e militari, visto che l’azienda italiana è controllata da un gruppo Usa?
In questa vicenda, la peculiarità di una azienda con sede in Italia ma con proprietà straniera – e non riconducibile a una realtà a caso, ma al colosso a stelle e strisce Collins Aerospace – induce a riflettere sulla posizione statunitense. È difficile immaginare che non vi fossero stati, in precedenza, scambi informali tra Parigi e Washington.
Il dubbio, dunque, che il governo italiano sia intervenuto su un’operazione che non infastidiva, per così dire, gli Stati Uniti, lasciandoli in qualche modo increduli, è legittimo. Proprio su Startmag ho letto un contributo che lanciava tale suggestione. Ma mi fermo qua.
Che tipo di ricorso – vista la reazione veemente della Francia contro la decisione del governo italiano – può avviare Safran?
I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali (dpcm) sono impugnabili innanzi al Tar Lazio. Ma è una strada impervia, se non disperata: i dpcm sono considerati dalla giurisprudenza atti di alta amministrazione e, per ciò solo, sindacabili solo nei limiti di una manifesta illogicità. Nel campo della difesa la discrezionalità in capo al governo è piuttosto estesa e, dunque, diventa difficile ottenere un annullamento del provvedimento (ad ora, l’unico annullamento in ambito golden power di cui si ha conoscenza è quello del caso Retelit, ma per motivi procedurali, non di merito).
Più interessante invece è la via comunitaria, in quanto un’opposizione in una operazione intra-Ue non passa inosservata. Astrattamente, nel settore della difesa è legittimo intervenire anche nei confronti di un soggetto comunitario. Però è una prerogativa che va maneggiata con cura e non mi stupirei se la Commissione intervenisse per fare quantomeno chiarezza. In un recente caso avente ad oggetto una opposizione sollevata dall’Ungheria, per ragioni di sicurezza nazionale, nei confronti di una impresa austriaca, la Commissione ha censurato proprio la qualifica da parte di Budapest dell’operazione come inerente al campo della sicurezza, ricordando che tale aspetto non può essere determinato unilateralmente.
Certo, nel caso ungherese si trattava di settore assicurativo, mentre qua trattasi di difesa in senso stretto. Ma questo suggerisce come la tolleranza delle istituzioni europee verso l’esercizio dei poteri speciali in operazione intra-Ue sia piuttosto bassa. E come la Commissione rappresenti, dunque, il migliore alleato degli acquirenti che dovessero vedere il proprio investimento vanificato da interventi governativi, come nel caso di Safran, specie se Roma ha omesso di attivare meccanismi collaborativi in buona fede con Parigi.