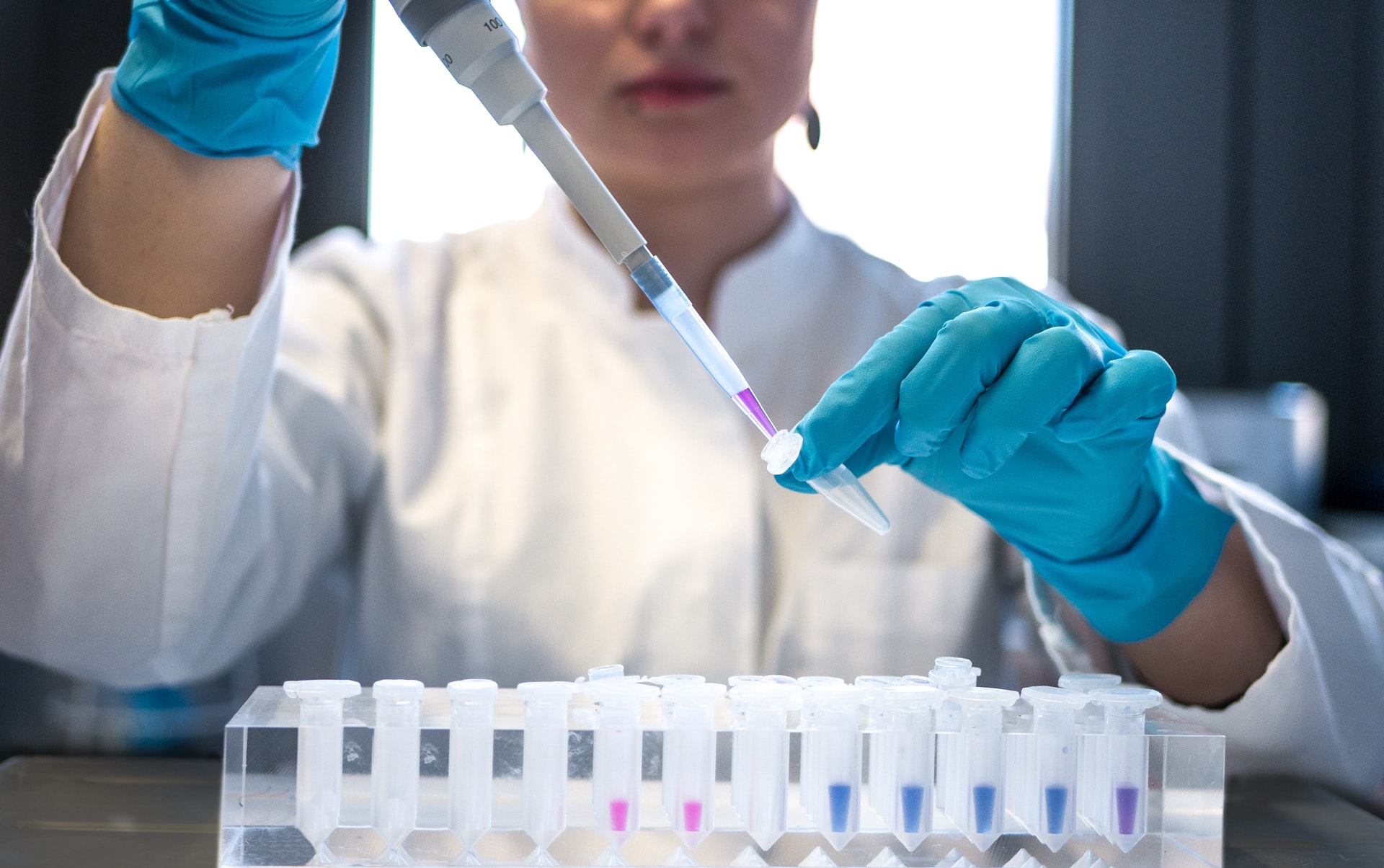La storia della politica e dell’economia non procede in modo lineare. Ma a scatti. Non accade nulla per anni e poi accade di tutto in poche settimane, addirittura pochi giorni.
Mentre andava in stampa l’intervento di Mario Draghi sul Financial Times di sabato, nelle stesse ore Ursula von der Leyen annunciava a sorpresa (c’era stata solo una informale discussionea porte chiuse nei giorni precedenti) la volontà di procedere con l’attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità, per consentire che le spese per la difesa siano escluse dai rigidi vincoli di spesa recentemente approvati dalla Commissione, obbedendo alle nuove regole del Patto di Stabilità riformato.
Tale volontà, che richiederà la maggioranza qualificata degli Stati membri per essere efficace, è stata poi confermata ieri dal suo vice-presidente Valdis Dombrov
In poche ore è stato messo in discussione uno dei pilastri fondativi della UE, cioè l’esigenza di consolidamento dei bilanci pubblici, di cui peraltro da poco sono state riscritte le regole. Draghi, da un lato, ha detto che senza lo stimolo dei bilanci pubblici non c’è crescita, la von der Leyen, dall’altro, ha detto che siamo in un’emergenza paragonabile, dal punto di vista economico, a quella del Covid. Al punto da ritenere soddisfatte le condizioni per l’attivazione di una clausola che consentirà di farsi beffe di regole riscritte solo da pochi mesi, dopo lunghe e frenetiche trattative.
Si avvera così la nostra previsione circa il fatto che quel Patto nascesse già vecchio. Inoltre i timori che quelle regole avrebbero danneggiato il nostro Paese erano, a nostro parere, da ridimensionare. Timori certamente fondati, ma altrettanto fondata era la previsione che sarebbero stati prima gli altri (Francia e Germania in testa) a lamentarsi e chiederne la disapplicazione. Cosa puntualmente avvenuta. Quella riforma del Patto di Stabilità non valeva nemmeno la carta su cui è stata stampata.
Ma c’è un “non detto” nei proclami ambiziosi di Draghi e von derLeyen: da dove si prendono i soldi e quanto costano. Infatti gli investitori pretendono un premio per il rischio di fronte a questi annunci di maggior debito. Che sia la Commissione a indebitarsi, o i singoli Stati (come consentito dalla clausola di salvaguardia del Patto), qualcuno dovrà pure sottoscrivere quei titoli e non lo farà se non adeguatamente remunerato.
Da quando girano queste voci di nuovi debiti, tutto il mercato dei titoli obbligazionari governativi si è “girato”. Il rendimento del Bund decennale tedesco è salito di 10/15 punti (complici le tensioni sulle imminenti elezioni politiche in Germania), così come il Btp e l’analogo titolo francese. Non esistono pasti gratis, fanno sapere dai mercati.
Allora von der Leyen si è messa a rovistare nella (semivuota) cassetta degli attrezzi e ha trovato circa 90 miliardi di prestiti già autorizzati per il Dispositivo di Ripresa e Resilienza adottato per la crisi Covid e mai richiesti dagli Stati membri (solo l’Italia ha richiesto l’intera quota disponibile). Ammesso e non concesso che gli Stati membri che finora hanno snobbato quei fondi vogliano ora utilizzarli e che sia giuridicamente possibile cambiarne la destinazione in tempi rapidi.
Parliamo comunque di 93 miliardi su una spesa per la difesa militare stimata in 500 miliardi in un decennio, meno di un quinto.
Allora, chi finanzierà quelle spese? Chi comprerà quei titoli? Semplice. C’è un unico sceriffo in città, quando si tratta di risolvere certi problemi. Si chiama Christine Lagarde e vive nell’Eurotower di Francoforte sul Meno.
Draghi e von der Leyen – quando si gonfiano il petto parlando di nuovo debito e deroghe al Patto – fanno finta di dimenticare (perché ovviamente lo sanno) che nel 2020-2022 quando ci fu l’attivazione della clausola di salvaguardia, quasi tutto il nuovo debito emesso per finanziare le maggiori spese e i tagli di imposte per superare la crisi Covid, fu comprato dalla Bce. Perché è l’unico soggetto in grado di creare denaro dal nulla, con un illimitato potere di aumentare le proprie passività, con cui può comprare di tutto. Tuttora, dopo 3 anni dal picco, la Banca d’Italia (operando come membro dell’Eurosistema) detiene ancora 637 miliardi di titoli del debito pubblico (pari al 26% del totale) che stanno andando lentamente a scadenza.
Per cui Draghi e von der Leyen la dicano tutta. L’unica fonte di finanziamento possibile per quella spesa di cui parlano è la moneta bancaria creata dalla Bce. Il resto sono sogni a cui i mercati non credono e per i quali comunque chiedono un prezzo.
A meno che qualcuno non stia pensando ad un impiego forzoso (un esproprio insomma) dei risparmi privati. Ma non vorremo dare idee pericolose.