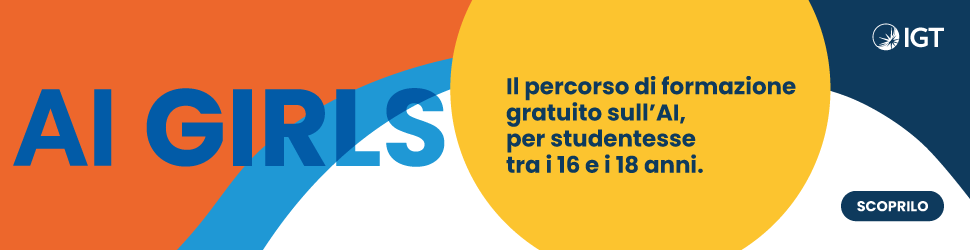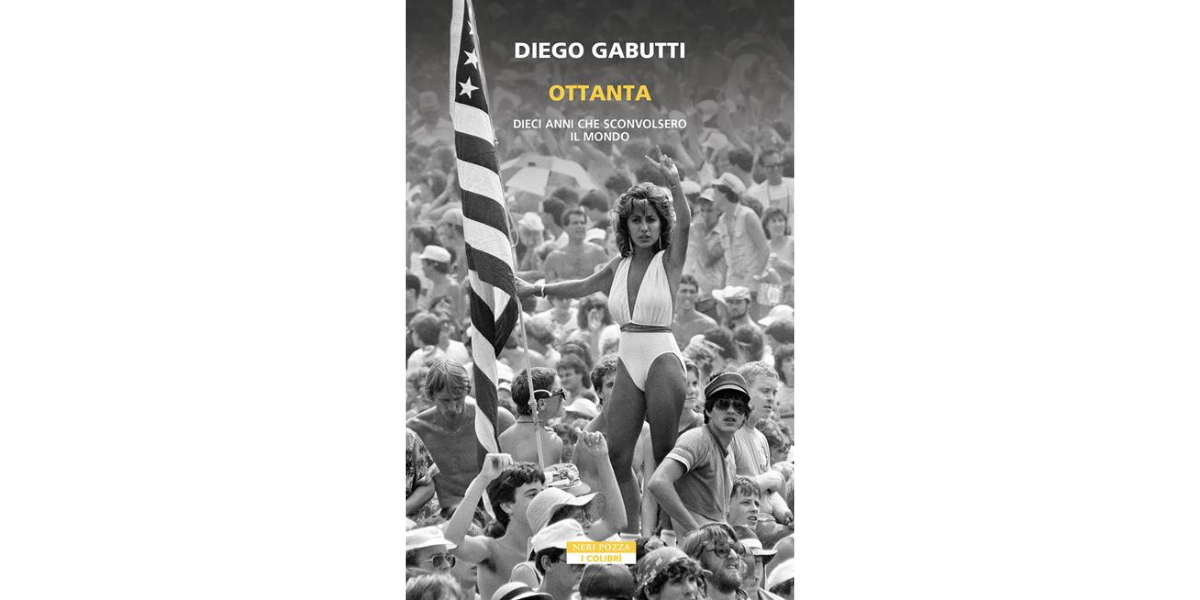Molti intellettuali, da Walter Mehring a Heinrich Mann, da Bertolt Brecht a Charlie Chaplin e Ernst Lubitsch, già negli anni Trenta del “secolo breve” avevano affilato le armi della satira contro il movimento delle camicie brune prima, e il regime nazista poi. Altri, che pure della satira erano maestri, ammutolirono di fronte all’ascesa di Hitler, ammettendo la sconfitta della loro arte. Karl Kraus si accomiatò dai suoi lettori nell’ottobre del 1933 con versi che, dalle pagine della sua rivista “Die Fackel” (La Fiaccola), formulavano la scelta del silenzio. Dopo la fine della guerra, Chaplin dichiarò che non avrebbe realizzato “Il grande dittatore” (1940) se fosse stato consapevole dell’incredibile mattanza che stava insanguinando in quegli anni l’Europa. L’umorismo, insomma, non era più ammissibile nella rappresentazione della Shoah.
Per altro verso, contro Paul Celan Theodor Adorno sostenne l’impossibilità di fare poesia dopo Auschwitz. Era un paradosso, usato per significare che ogni tentativo di descrivere l’orrore dei campi di sterminio ricorrendo all’arte era destinato al fallimento; e che, anzi, lo stesso ricorso all’arte costituiva un’offesa alla memoria delle vittime della “Soluzione finale”. Celan si oppose al divieto e creò quella lirica del lamento nel silenzio infinito che è “Todesfuge” (“Fuga di morte”, iniziata nel 1945), rifiutando per anni di incontrare Adorno. Questi riconobbe più tardi la velleità della propria prescrizione. Primo Levi, a sua volta, gli contestò di essere caduto in contraddizione per aver emesso una sentenza di condanna usando comunque la parola scritta, e ribatté che l’unica poesia possibile su Auschwitz era proprio quella di Celan (Enzo Traverso, “Auschwitz e gli intellettuali. La Shoah nella cultura del dopoguerra”, il Mulino, 2004).
Eppure nella Germania del Terzo Reich, nell’Austria dell’Anschluss, nei territori occupati dalla Wehrmacht ed esposti ai venti della deportazione e dell’annientamento, l’umorismo aveva assunto il ruolo di strumento -spesso unico- di resistenza all’oppressore. Hitler si dimostrò particolarmente sensibile nei confronti del potere invasivo del “witz”, della battuta di spirito in grado di spogliare la sua autorità dell’alone mitico di cui si ammantava. Contro un diffuso umorismo popolare che si manifestava nei “Flüsterwitze”, barzellette che venivano sussurrate a voce bassa spandendo un veleno mortale sulla propaganda del partito, la dirigenza nazionalsocialista combatté su più fronti, ammettendo implicitamente di trovare nel riso beffardo, demistificante e corrosivo un avversario assai temibile da sconfiggere ad ogni costo. Già nel dicembre del 1934 era stata approvata la “Legge contro gli attacchi diffamatori allo Stato e al Partito”, che prevedeva pene pecuniarie e detentive (in galera o nei “rieducativi” campi di concentramento) fino a due anni. Nel mirino del legislatore entrava così chiunque fosse coinvolto, a vario titolo, nella produzione e nella diffusione di affermazioni false e distorte “atte a minare il benessere del Reich, la credibilità del suo governo e delle sue disposizioni, del partito nazionalsocialista e dei suoi dirigenti”.
Le barzellette politiche diventarono pertanto reati perseguibili penalmente; raccontarle o anche semplicemente ascoltarle costituiva un atto di resistenza e di coraggio che poteva però costare caro. I “Flüsterwitze” avevano bersagli diversi e un obiettivo comune. A essere presi di mira erano anzitutto i vertici del partito e del governo: Hitler in testa, seguito da Goebbels, suo onnipotente ministro della propaganda, e Goering, capo dell’aviazione tedesca. I componenti di questo terzetto, ribattezzati dal mordace umorismo popolare rispettivamente come “der Mächtige” (il potente), “der Prächtige” (lo splendido), “der Schmächtige” (il gracilino) erano raffigurati nelle barzellette da soli, in trio o dialoganti con personalità del Reich e capi di stato stranieri. Il motto di spirito giocava con i loro umanissimi difetti, mettendo alla berlina l’inestinguibile sete di potere del Führer, la corpulenza di Goering e il suo marcato narcisismo (pare avesse un debole per divise e decorazioni militari), come pure il suo coinvolgimento nell’incendio del Reichstag (marzo 1933). Goebbels era invece al centro di battute per la sua attività menzognera di ministro della propaganda e per le sue famose avventure extra-coniugali, che contrastavano platealmente con la moralità puritana predicata dal regime e con lineamenti lontani dai modelli della razza ariana.
Il compito di queste barzellette politiche non era allora più quello di schernire la tirannia, di ridicolizzarla per ridurla -con quel riso sovversivo che può capovolgere i rapporti di potere- a un nemico meno temibile e, in fin dei conti, vincibile. Esse fungevano piuttosto da risorsa cui attingere per esorcizzare il terrore e arginare il peso schiacciante delle privazioni quotidiane. Nonostante le leggi razziali, il boicottaggio dei negozi, il brutale pogrom ribattezzato dagli aguzzini con il nome romantico di “Kristallnacht” (Notte dei cristalli), la reclusione nei ghetti e nei campi di sterminio, si affinò un umorismo ebraico intriso di speranza e insieme di disperazione, che rifletteva la caparbia volontà di non arrendersi, di non rinunciare a una scintilla di dignità anche di fronte a una totale disumanizzazione.
Questa capacità di reagire col sorriso alle inclemenze della vita era il frutto di una precisa realtà storica, sociale e culturale, quella delle comunità orientali degli ebrei ashkenaziti che, nella seconda metà dell’Ottocento, trascorrevano nei villaggi (“Shtetlakh”) un’esistenza quotidiana fatta di discriminazioni e persecuzioni, forzatamente isolata rispetto al mondo circostante. È in quei villaggi, sulla scia di importanti influenze mistico-religiose derivate dal Chassidismo, che si forma una generosa tradizione di risate sagge, amare e dissacranti persino sui profeti e sull’Altissimo, che rivelavano una vocazione ironico-introspettiva che Freud fu il primo a analizzare.
Subito dopo l’Olocausto, l’umorismo yddish è costretto a rivedere i suoi stilemi. Le stesse opere degli scrittori-testimoni sono come sospese tra parola e silenzio. Una condizione angosciosa, denunciata da Primo Levi nell’incipit di Se questo è un uomo, che oscillava tra l’impossibilità di trovare un linguaggio adeguato all’abominio del lager e l’imperativo categorico della sua descrizione. Al di là del Reno, solo più tardi Edgar Hilsenrath, un ebreo nato a Lipsia nel 1926, internato per due anni nel ghetto di Černivci in Buocovina, inguaribile giramondo, sfiderà il senso di colpa e la riottosità dei suoi connazionali a “elaborare il lutto” del nazismo con un romanzo provocatorio, che sovvertiva i canoni narrativi dello sterminio. Si intitola “Der Nazi & der Friseur”, e non per caso viene pubblicato nel 1971 dalla casa editrice Doubleday in lingua inglese. Diventa subito un best seller internazionale (due milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti), mentre dovrà attendere sei anni e subire l’onta di sessanta rifiuti prima che un giovane e coraggioso editore, Helmut Braun, lo faccia conoscere al pubblico tedesco. Tradotto per la prima volta in italiano da Mondadori nel 1973, “Il nazista e il barbiere” è stato recentemente ristampato da Marcos Y Marcos.
Il suo protagonista, Max Schulz, ci fa sapere di essere nato nella cittadina tedesca di Wieshalle nel 1907, nello stesso giorno in cui, nella casa dei vicini Finkelstein, viene alla luce il piccolo Itzig. Figlio di una donna di facili costumi, Max è incerto sull’esatta identità del padre, ma è sicuro della sua discendenza ariana “purissima”, poiché tanto l’albero genealogico della madre quanto quello dei cinque possibili genitori maschi sono stati accuratamente verificati. Regolarmente violentato sin dalla più tenera infanzia da Slavitzki, il patrigno mostruosamente superdotato, stringe ben presto amicizia con Itzig e frequenta assiduamente la sua abitazione, familiarizzando con le tradizioni religiose degli ebrei praticanti. Quando arriva il momento di imparare un mestiere, i due inseparabili amici iniziano a lavorare nel salone del barbiere Chaim Finkelstein. Con l’avvento al potere dei nazisti l’apparente equilibrio si rompe: Max, che fiuta il vento che cambia, entra a far parte delle SA e poi delle SS, combatte nel Secondo conflitto mondiale, partecipa alle esecuzioni di massa degli ebrei nell’Europa orientale e presta servizio presso nel lager di sterminio di Laubwalde, in Polonia, massacrando proprio la famiglia Finkelstein.
Terminata la guerra, il carnefice torna in Germania e assume l’identità di Itzig. Decide di lasciare suo paese per rifugiarsi là dove nessuno lo avrebbe mai cercato: in Palestina tra gli ebrei della diaspora, diventando un terrorista al servizio della causa sionista e, in seguito, un soldato del neonato esercito israeliano. Il sogno di una tranquilla e “onesta” vita borghese si concretizza con un impiego come barbiere a Beth David e con il matrimonio con Mira, la nipote del proprietario del salone. Nessuno sospetta del suo passato, ma le sue vittime non concedono tregua alla sua coscienza: alla fine è lo stesso carnefice a cercare un processo e una giusta condanna, confessando la sua vera identità e i crimini compiuti. Non gli crede nessuno. Colpito da infarto, gli viene trapiantato il cuore di un rabbino, ma non riesce a salvarsi.
Come sottolinea Cecilia Morelli in un saggio magistrale (di cui sono debitrici queste note), non c’è da stupirsi che un romanzo come questo abbia incontrato forti ostilità in Germania (“Un riso che turba e disturba: Der Nazi & der Friseur di Edgar Hilsenrath e Mein Kampf di George Tabori. Esempi di grottesco e witz nella letteratura della Shoah”, Università di Bergamo, disponibile in pdf). Perché a parlare in prima persona è un “Massenmörder”, un pluriomicida privo di ogni scrupolo morale. Perché, inoltre, il suo timbro grottesco e il suo umorismo nero si prefiggono di scioccare, non di compiacere il lettore. Ad esempio, per indagare le sue origini Max si serve del metodo messo a punto dal regime per accertare l’identità ariana attraverso un vaglio meticoloso degli avi. È proprio l’ottusa e zelante applicazione di questo metodo a smascherarne l’assurdità, e a trasformare Max in una macchietta che ripete ossessivamente “sicher ist sicher” (la certezza non è mai troppa). Del resto, la demolizione dello stereotipo antisemita è uno dei motivi centrali del romanzo. Tant’è che l’aspetto fisico di Max somiglia a quello dell’ebreo dal “naso adunco”, mentre Itzig incarna l’idealtipo di razza ariana codificato da Rudolph Hess.
Nel suo discorso, Hilsenrath si rivolge sia agli innocenti che ai colpevoli. E il suo è un discorso che allude al problema di fondo che la Shoah ha posto alla civiltà occidentale, ovvero il problema che Hanna Arendt ha chiamato “la banalità del male”. Quel che infatti nel romanzo spiazza è la naturalezza, l’assenza emotiva con cui Max illustra le sue imprese criminali e la sua carriera di macellaio impietoso. Nondimeno, Hilsenrath non mitiga e non nasconde l’orrore del genocidio. Al contrario, utilizza un cupo umorismo propro per renderne più vivida e evidente la portata catastrofica. Con Il nazista e il barbiere una comicità irriverente, e le sue enormi potenzialità critiche, fanno il loro ingresso in un recinto da sempre considerato sacro e inviolabile.
Non sono solo testi prevalentemente letterari a testimoniare una maggiore apertura in questo senso. Basti pensare agli scritti del praghese Maxim Biller, che esplorano con tagliente ironia la convivenza tra ebrei e tedeschi nella Germania riunificata. Si pensi, ancora, al fumetto “Maus” di Art Spiegelman (dove gli ebrei sono topi, i nazisti gatti). Sono espressione di un modo non convenzionale di trattare un argomento delicatissimo come la memoria della Shoah. Infine, il cinema. La “settima arte” (copyright di Ricciotto Canudo, 1921) ha mostrato un precoce interesse per il “riso scomodo”, più avanti suffragato da film come il notissimo “La vita è bella” di Roberto Benigni (1997) e il forse meno famoso -ma, a giudizio di chi scrive, più incantevole- “Train de vie”, una coproduzione europea firmata dal regista rumeno Radu Mihaileanu (1998).
Il successo di queste opere conferma la definitiva legittimazione del ricorso all’umorismo nell’affrontare temi tanto estremi. Non va però neanche sottovalutato il peso rilevante dei dubbi e delle antipatie che esse continuano a incontrare. Novelle, fumetti, film di animazione o film da Oscar sul genocidio che percorrono i sentieri dell’umorismo sono sempre sottoposti a un doppio controllo. Infatti, insieme alle valutazioni sulla loro qualità artistica, incombe ostinato l’interrogativo moraleggiante che ha segnato tante recensioni del romanzo di Hilsenrath: “Darf man das?” (È lecito?). Dopo la carneficina dei miliziani di Hamas del 7 ottobre scorso nei kibbutz israeliani, è assai difficile che la stessa domanda si possa riproporre entro un ragionevole lasso di tempo. Marx asseriva che storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa. Si sbagliava: anche la seconda può ripetersi come tragedia.
*Il Foglio