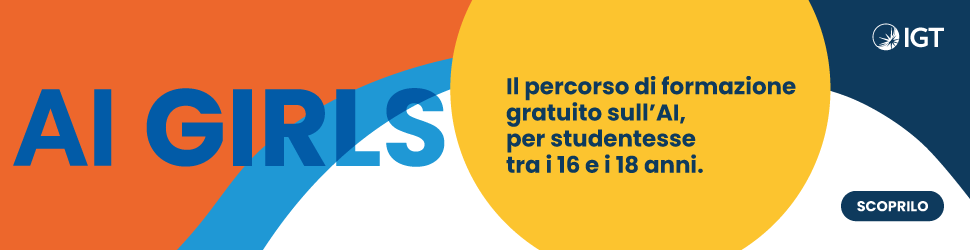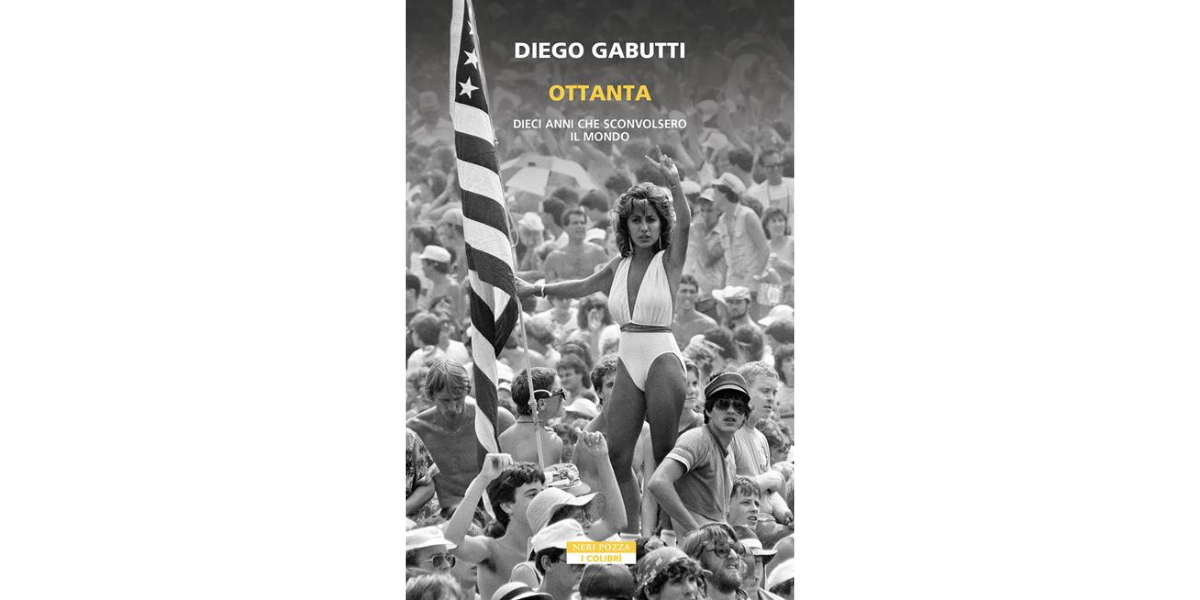A Confindustria per la sua proposta riguardante la presentazione del green pass per accedere al lavoro, si può rivolgere solo una critica di metodo: la gestione della pandemia è avvenuta sulla base di protocolli concordati con le organizzazioni sindacali e il governo, che hanno consentito di riaprire – in relativa sicurezza – le aziende manifatturiere dopo il lockdown.
Sarebbe pertanto opportuno proseguire con questo metodo senza iniziative unilaterali. Ma i tempi stringono: se ne devono rendere conto anche i sindacati. Se il governo dispone regole che valgono per tutti i cittadini, è ovvio che i luoghi di lavoro non possono essere una zona franca. Non ha senso affermare – come hanno dichiarato alcuni sindacalisti – che fino a oggi si è lavorato al chiuso e che quindi si può continuare così.
Ad aprile dell’anno scorso – quando sono stati sottoscritti i Protocolli – non c’erano i vaccini, mentre oggi sono disponibili. Io condivido – per come le ho comprese – le considerazioni di Walter Ricciardi nella sua intervista su HuffPost. A mio avviso per regolare la materia – nel mondo del lavoro – sono sufficienti le disposizioni già in vigore, nel senso che l’obbligo di vaccinazione (e non solo nelle strutture sanitarie e sociali, come la scuola) è parte integrate dei doveri che, in un normale rapporto di lavoro, gravano sul datore e di conseguenza sui dipendenti. I datori devono adempiere a quanto stabilito dall’articolo 2087 del codice civile che recita:
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Si tratta di una ‘’norma di chiusura’’ della tutela antinfortunistica, usata in questi casi da tutte le procure anche non sussistevano evidenti violazioni di legge (si pensi alla vicenda dell’amianto): all’imprenditore, per essere affrancato da responsabilità penali e civili, non basta limitarsi a rispettare le leggi vigenti in tema di sicurezza del lavoro.
L’orizzonte dell’articolo citato è quello della particolarità, dell’esperienza e della tecnica e delle indicazioni che ne derivano anche nel silenzio del legge. All’inizio della pandemia un decreto ha stabilito che il contagio contratto ‘’in occasione di lavoro’’ (quindi anche in itinere sui mezzi di trasporto) è da considerare infortunio sul lavoro a tutti gli effetti (ci sono state 147mila denunce e 500 morti).
La norma dell’infortunio da covid-19 avrebbe potuto mettere le aziende in una condizione di responsabilità oggettiva, se non si fosse chiarito, in un provvedimento successivo, che:
“Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo (…) sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni’’.
In sostanza il legislatore ha ritenuto necessario fornire una sorta di interpretazione autentica dell’applicazione dell’articolo 2087, proprio per le preoccupazioni espresse dal mondo dell’impresa. A questo punto, si può ricapitolare: il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2087 citato, è tenuto ad adottare tutte le misure che, a prescindere da quanto è recepito e indicato dalla legge, possono tutelare la sicurezza del lavoratore; il contagio da Covid-19, se contratto in occasione di lavoro, è considerato infortunio, dalla cui responsabilità il datore si sottrae se gli è riconosciuto di avere applicato correttamente quanto disposto nei Protocolli.
Nell’ambito delle misure di tutela è subentrata la disponibilità di vaccini, regolarmente testati dalle autorità competenti: una misura frutto della ’’esperienza e della tecnica’’. Sorge allora un obbligo in capo al datore (pubblico o privato) per rimettere in maggior sicurezza i propri dipendenti. Quando nell’ambito del rapporto di lavoro una delle parti – nel nostro caso il prestatore – si sottrae a un obbligo contrattuale mettendo a rischio la sua salute e quella dei suoi colleghi, al datore di lavoro – che è comunque responsabile della sicurezza della comunità aziendale – non è consentito di cavarsela dicendo: ‘’Io la vaccinazione gliela voleva fare, ma lui si è rifiutato’’.
L’azione del dipendente non esonera il datore nel caso che dal contagio/infortunio derivi un danno grave o il decesso del dipendente stesso e di altri colleghi contagiati; ma quell’indisponibilità gli impedisce di adempiere ad un obbligo corredato di sanzioni penali.
In caso di rifiuto conclamato – di uno o più dipendenti – di sottoporsi alla vaccinazione, quando ormai è accertato che con la pandemia dovremo convivere a lungo, non pare esservi una soluzione diversa dalla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo (e quindi sottratto ad ogni regime di blocco) da parte del datore.
Perché, a pensarci bene, è improbabile pure il trasferimento ad altra mansione proprio per la natura stessa del contagio. Non dimentichiamo che è considerato infortunio sul lavoro anche l’infezione contratta dal dipendente, renitente al vaccino, sulla metropolitana che lo porta in azienda o lo riporta a casa. Magari, è possibile avvalersi dell’esperienza dello smart working: ma non tutte le mansioni sono compatibili.
Poi non è il caso di andare avanti con questa modalità per anni, con dei dipendenti rinchiusi a domicilio come i soldati giapponesi scoperti, a guerra finita, in un’isola deserta. Vogliamo, forse, tornare all’esperienza dei ‘’reparti confino’’ (una volta sede delle discriminazioni politiche e sindacali) dove collocare i dipendenti No Vax?
Articolo pubblicato su huffingtonpost.it